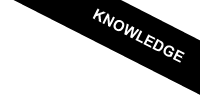Esercizi svolti sullo studio del limite
Un elenco di esercizi svolti sullo studio del limite di una funzione.
| Esercizio | limx→3x2−3xx−3 |
| Esercizio | limx→2x2−4x−2 |
| Esercizio | limx→0√x+4−23x |
| Esercizio | limx→0√x−4−23x |
| Esercizio | limx→0x3−x2+4xx5−x |
| Esercizio | limx→93−√x9−x |
| Esercizio | limx→−∞2x−√4x2+x |
| Esercizio | limx→+∞√x2+3x−4−x |
| Esercizio | limx→−5x2+3x−10x2−25 |
| Esercizio | limx→0log√x+1x |
| Esercizio | limx→+∞x+2−√x2+4x+8 |
| Esercizio | limx→−13x2+x−10x2−5x−14 |
| Esercizio | limx→2√x2−2x+9−3x3−x2−x−2 |
| Esercizio | limx→−1√x2+3−23−√8−x3 |
| Esercizio | limx→0sin(x)x |
| Esercizio | limx→0sin(3x)x |
| Esercizio | limx→0√1+x−1x |
| Esercizio | limx→01−cos(3x)x2 |
| Esercizio | limx→0sin(x)−xx3 |
| Esercizio | limx→01−cos(x)x2 |
| Esercizio | limx→0cos(x)−1x |
| Esercizio | limx→π4tan(x)−1x−π4 |
| Esercizio | limx→0sinxex−1 |
| Esercizio | limx→2√x2+5−√x3+12x−x2 |
| Esercizio | limx→03−√9−x22√1+x2−√4+x2 |
| Esercizio | limx→0(e3x−1)sinx4x2log(1+x3) |
| Esercizio | limx→∞x+sin(x)x−cos(x) |
Esercizio 1
Devo calcolare il limite per x che tende 3 della funzione fratta
limx→3x2−3xx−3
Il dominio della funzione è (-∞, 3)∪(3,+∞).
Il punto x0=3 non appartiene al dominio della funzione ma è un punto di accumulazione della funzione. Quindi posso calcolare il limite.
Il limite è una forma indeterminata del tipo 0/0
limx→3x2−3xx−3=00
Per uscire dalla forma indeterminata fattorizzo il numeratore mettendo in evidenza la x
limx→3x⋅(x−3)x−3
In questo modo posso semplificare ed eliminare (x-3) sia al numeratore che al denominatore.
limx→3x
Ora il limite è calcolabile ed è pari a 3
limx→3x=3
Esercizio 2
Devo studiare il limite per x che tende a due della funzione fratta
limx→2x2−4x−2
Il dominio della funzione è (-∞,2)∪(2,∞)
Il punto x=2 è un punto di accumulazione della funzione. Quindi, posso calcolare il limite.
Il limite per x→2 è una forma indeterminata del tipo 0/0
limx→2x2−4x−2=00
Per uscire dalla forma indeterminata, scompongo il numeratore nel prodotto di due binomi.
limx→2(x−2)⋅(x+2)x−2
Poi semplifico x-2 al numeratore e al denominotore.
limx→2(x+2)
In questa forma equivalente il limite è facilmente calcolabile
limx→2(x+2)=4
Il limite per x→2 converge al numero finito 4.
Esercizio 3
Devo studiare il limite per x che tende a zero di questa funzione
limx→0√x+4−23x
Per prima cosa trovo il dominio della funzione.
La funzione è definita nell'intervallo
Df=[−4,0) ∪ (0,+∞)
Poi verifico se il limite ha una soluzione immediata per x→0.
limx→0√x+4−23x=00
Il limite è una forma indeterminata del tipo 0/0. Quindi, non ha una soluzione immediata.
Per evitare la forma indeterminata trasformo il limite in una forma equivalente.
Moltiplico e divido la funzione per il numeratore cambiando il segno da meno a più.
limx→0√x+4−23x⋅√x+4+2√x+4+2
In questo modo il numeratore si semplifica
limx→0√x+4√x+4+2√x+4−2√x+4−43x(√x+4+2)
limx→0(x+4)−43x(√x+4+2)
limx→0x3x(√x+4+2)
limx→013(√x+4+2)
Ora posso calcolare il limite nella forma equivalente evitando la forma indeterminata.
limx→013(√x+4+2)=112
Il limite della funzione per x che tende a zero è 1/12.
Nota. Per risolvere la forma indeterminata 0/0 posso usare anche il teorema di L'Hopital derivando separatamente sia il numeratore che il denominatore della funzione fratta. limx→0√x+4−23x=00 limx→0D[√x+4−2]D[3x] limx→012⋅√x+43=12⋅√43=143=14⋅13=112 Il risultato finale è lo stesso.
Esercizio 4
Devo studiare il limite per x che tende a zero della funzione
limx→0√x−4−23x
Per prima cosa analizzo il dominio della funzione.
La funzione è definita nell'intervallo
Df=[4,+∞)
La radice quadrata è definita solo per maggiori o uguali di zero (x-4)≥0.
Quindi la funzione è definita solo per valori x≥4.
E' quindi impossibile studiare il limite della funzione per x→0 perché nell'intorno di zero la funzione non è definita.
Lo studio del dominio mi ha permesso di giungere facilmente alla soluzione senza dover studiare il limite.
Nota. Con questo esercizio banale voglio semplicemente dimostrare l'importanza dello studio del dominio della funzione prima dello studio del limite. Spesso si studia il limite senza considerare il dominio ed è una trascuranza che fa perdere molto tempo in calcoli inutili. A volte la soluzione è immediata.
Esercizio 5
Devo studiare il limite per x→0 della funzione fratta
limx→0x3−x2+4xx5−x
Dove x=0 è un punto di accumulazione non appartenente al dominio della funzione.
Il limite è una forma indeterminata del tipo 0/0
limx→0x3−x2+4xx5−x
Per evitare la forma indeterminata, metto in evidenza la x al numeratore e al denominatore.
limx→0x(x2−x+4)x(x4−1)
In questo modo posso semplificare eliminando la x sia al numeratore che al denominatore.
limx→0x2−x+4x4−1
Ora il limite è calcolabile ed è un numero finito.
limx→0x2−x+4x4−1=4−1=−4
Il limite della funzione fratta per x che tende a zero è -4.
Esercizio 6
In questo esercizio devo risolvere il limite di questa funzione
limx→93−√x9−x
Il dominio della funzione è
Df[0,9)∪(9,+∞)
Spiegazione. La radice quadrata non può assumere come argomento un numero negativo. Il denominatore della funzione fratta si annulla per x=9. Quindi x=9 non fa parte del dominio della funzione.
Il numero x0=9 è un punto di accumulazione della funzione.
Quindi, posso procedere col calcolo del limite.
limx→93−√x9−x=00
Il limite è una forma indeterminata del tipo 0/0.
Cerco di eliminare la forma indeterminata razionalizzando il numeratore.
Moltiplico e divido per il numeratore cambiato di segno 3+√x.
limx→93−√x9−x⋅3+√x3+√x
limx→9(3−√x)⋅(3+√x)(9−x)⋅(3+√x)
limx→9(9+3√x−3√x−(√x)2)(9−x)⋅(3+√x)
limx→99−x(9−x)⋅(3+√x)
Semplifico eliminando 9-x al numeratore e al denominatore
limx→913+√x
In questo modo ottengo la funzione in una forma equivalente che non presenta la causa della forma indeterminata.
Ora posso calcolare il limite.
limx→913+√x=16
Il limite della funzione per x→9 è 1/6.
Nota. Per eliminare la forma indeterminata 0/0 avrei anche potuto applicare il teorema di L'Hopital. limx→93−√x9−x=00 Per eliminare la forma indeterminata 0/0 calcolo la derivata del numeratore e del denominatore. limx→9D[3−√x]D[9−x]=limx→9−12√x−1=limx→912√x=16 La soluzione è la stessa.
Esercizio 7
In questo esercizio studio il limite per x→-∞ della funzione
limx→−∞2x−√4x2+x
Questo limite può trarre in inganno
Il primo termine 2x tende a -infinito per x→-∞.
Il radicando 4x2+x sembrerebbe una forma indeterminata del tipo ∞-∞ perché 4x2 tende a infinito mentre +x tende a meno infinito.
limx→−∞2x−√4x2+x=−∞−√∞−∞
In realtà, per risolvere il problema mi basta riscrivere l'espressione del limite in questa forma equivalente mettendo in evidenza la x nel radicando
limx→−∞2x−√x2(4+1x)
In questo modo il termine +1/x tende a zero e il radicando tende a +∞.
In alternativa. In un limite per x che tende a più o meno infinito di un polinomio prevale sempre asintoticamente il termine di grado più alto del polinomio. Tutti gli altri si possono ignorare. In questo caso il limite tende a meno infinito e il radicando è un polinomio di grado 2. Quindi, posso considerare il monomio di grado più alto (4x2) del polinomio e ignorare gli altri (x). limx→−∞√4x2+x=limx→−∞√4x2=+∞
In questa forma equivalente il limite iniziale non ha alcuna forma indeterminata ed è facilmente calcolabile.
limx→−∞2x−√x2(4+1x)=−∞−(+∞)=−∞−∞=−∞
Il limite della funzione per x che tende a meno infinito è -∞.
Esercizio 8
In questo esercizio devo risolvere il limite della funzione per x→∞.
limx→+∞√x2+3x−4−x
Il limite è una forma indeterminata infinito meno infinito ∞-∞
limx→+∞√x2+3x−4−x=∞−∞
Per risolvere il limite devo eliminare la forma indeterminata.
Moltiplico e divido per la somma dei due termini.
limx→+∞√x2+3x−4−x⋅√x2+3x−4+x√x2+3x−4+x
limx→+∞(√x2+3x−4−x)⋅(√x2+3x−4)+x)√x2+3x−4+x
limx→+∞√x2+3x−4√x2+3x−4+x√x2+3x−4−x√x2+3x−4−x2√x2+3x−4+x
limx→+∞(√x2+3x−4)2−x2√x2+3x−4+x
limx→+∞x2+3x−4−x2√x2+3x−4+x
limx→+∞3x−4√x2+3x−4+x
Ora la funzione è una funzione fratta ma si verifica un'altra forma indeterminata del tipo ∞/∞
limx→+∞3x−4√x2+3x−4+x=∞∞
Per uscire da quest'ultima forma indeterminata fattorizzo il numeratore della funzione fratta per x.
limx→+∞x(3−4x)√x2+3x−4+x
Poi fattorizzo il denominatore della funzione fratta per x.
limx→+∞x(3−4x)√x2⋅(1+3x−4x2)+x
limx→+∞x(3−4x)x⋅√(1+3x−4x2)+x
limx→+∞x(3−4x)x⋅(√(1+3x−4x2)+1)
Quindi elimino la x al numeratore e al denominatore.
limx→+∞3−4x√(1+3x−4x2)+1
In questo modo elimino anche la forma indeterminata ∞/∞.
Ora il limite è calcolabile e converge a un numero finito.
limx→+∞3−4x√(1+3x−4x2)+1=32
Il limite della funzione è 3/2.
Esercizio 9
Devo studiare il limite di questa funzione fratta
limx→−5x2+3x−10x2−25
Per prima cosa, individuo il dominio della funzione
Df(−∞,−5)∪(−5,5)∪(5,+∞)
Nei punti 5 e -5 la funzione non è definita perché si annulla il denominatore.
Il numero x0=-5 è un punto di accumulazione della funzione.
Quindi, posso procedere col calcolo del limite.
limx→−5x2+3x−10x2−25=00
Il limite della funzione è la forma indeterminata del tipo 0/0.
Riscrivo la funzione in una forma equivalente per evitare la forma indeterminata.
Scompongo il numeratore con il metodo di Ruffini.
limx→−5x2+3x−10x2−25
limx→−5(x−2)⋅(x+5)x2−25
Il denominatore è una differenza di quadrati (a2-b2)=(a-b)(a+b)
limx→−5(x−2)⋅(x+5)x2−52
limx→−5(x−2)⋅(x+5)(x−5)⋅(x+5)
Semplifico togliendo (x+5) al numeratore e al denominatore
limx→−5x−2x−5
Infine, calcolo il limite per x che tende a -5
limx→−5x−2x−5=−7−10=710
Ho evitato la forma indeterminata 0/0
Il limite della funzione è 7/10.
Nota. Essendo una forma indeterminata 0/0 avrei potuto risolvere il limite anche con il teorema di L'Hopital. limx→−5x2+3x−10x2−25=00 limx→−5D[x2+3x−10]D[x2−25] limx→−52x+32x=−7−10=710 Il risultato è lo stesso.
Esercizio 10
In questo esercizio devo studiare il limite della funzione
limx→0log√x+1x
Il dominio della funzione è
Df=(−1,0)∪(0,+∞)
Il punto x=0 è un punto di accumulazione della funzione. Quindi posso procedere con lo studio del limite.
Il limite è una forma indeterminata 0/0
limx→0log√x+1x=00
Per risolvere il limite devo eliminare la forma indeterminata 0/0.
Esistono diverse strade per risolvere il limite.
Ad esempio, moltiplico e divido la funzione per 2.
limx→0log√x+1x⋅22
Per la regola del prodotto del logaritmo a·log(b)=log(ba)
limx→02⋅log√x+1x⋅12
limx→0log(√x+1)2x⋅12
limx→0log(x+1)x⋅12
Il termine 1/2 è una costante e può uscire dal limite
12⋅limx→0log(x+1)x
In questo modo ho ricondotto il limite al limite notevole log(x+1)/x = 1
12⋅1
12
Pertanto, il limite è 1/2
limx→0log√x+1x=12
Nota. Essendo una forma indeterminata 0/0 potevo risolvere il limite anche con il teorema di L'Hopital. limx→0log√x+1x=limx→0D[log√x+1]D[x] Al denominatore c'è una semplice derivata D[x]=1. =limx→0D[log√x+1]1 =limx→0D[log√x+1] Al numeratore c'è la derivata di una funzione composta. Quindi calcolo la derivata del logaritmo per la derivata del suo argomento ossia la derivata della radice quadrata =limx→01√x+1⋅12√x+1 =limx→012√x+1⋅√x+1 =limx→012(x+1) =12
Metodo alternativo
Per risolvere il limite posso seguire anche un'altra strada.
limx→0log√x+1x
E' un po' più lunga e complessa ma è utile per esercitarsi.
Cerco di ricondurla al limite notevole log(x+1)/x.
Sommo e sottraggo 1 nell'argomento del logaritmo.
limx→0log[1−1+√x+1]x
limx→0log[1+(√x+1−1)]x
Ora moltiplico e divido per √(x+1)-1
limx→0log[1+(√x+1−1)]x⋅√x+1−1√x+1−1
limx→0log[1+(√x+1−1)]√x+1−1⋅√x+1−1x
La prima componente è un limite notevole generalizzato log(1+f)/f = 1
Dove f=√(x+1)-1 è una funzione infinitesima per x→0
limx→0log[1+(√x+1−1)]√x+1−1⋅limx→0√x+1−1x
1⋅limx→0√x+1−1x
limx→0√x+1−1x
Ho eliminato il logaritmo ma il limite è ancora una forma indeterminata 0/0
limx→0√x+1−1x=00
Per uscire dalla forma indeterminata moltiplico e divido per il numeratore trasformando la differenza in somma
limx→0√x+1−1x⋅√x+1+1√x+1+1
limx→0(√x+1−1)⋅(√x+1+1)x⋅(√x+1+1)
limx→0√x+1√x+1+√x+1−√x+1−1x⋅(√x+1+1)
limx→0x+1−1x⋅(√x+1+1)
limx→0xx⋅(√x+1+1)
Semplifico la x al numeratore e denominatore
limx→01√x+1+1
Ora il limite per x→0 è calcolabile
limx→01√x+1+1=12
Il limite della funzione è 1/2.
Nota. Questo dimostra che un limite può essere risolto seguendo varie strade con tecniche diverse. Alcune sono più facili e rapide, altre più complesse e lunghe. Il risultato finale è comunque sempre lo stesso.
Esercizio 11
limx→+∞x+2−√x2+4x+8
Il limite è una forma indeterminata del tipo infinito meno infinito ∞-∞
limx→+∞x+2−√x2+4x+8=∞−∞
Per uscire dalla forma indeterminata moltiplico e divido per la somma dei termini
limx→+∞x+2−√x2+4x+8⋅x+2+√x2+4x+8x+2+√x2+4x+8
limx→+∞(x+2−√x2+4x+8)⋅(x+2+√x2+4x+8)x+2+√x2+4x+8
limx→+∞(x+2)2−(√x2+4x+8)2x+2+√x2+4x+8
limx→+∞(x2+4x+4)−(x2+4x+8)x+2+√x2+4x+8
limx→+∞x2+4x+4−x2−4x−8x+2+√x2+4x+8
limx→+∞−4x+2+√x2+4x+8
La forma indeterminata è scomparsa.
Ora il limite è calcolabile.
limx→+∞−4x+2+√x2+4x+8=−4∞+∞=−4∞=0
Il limite della funzione per x→∞ è zero.
Esercizio 12
Devo studiare il limite per x→-2 della funzione fratta
limx→−23x2+x−10x2−5x−14
Il dominio della funzione è l'insieme dei numeri reali meno le radici dell'equazione di 2° grado al denominatore x^2-5x-14
x=5±√25−4(−14)2
x=5±√25+562
x=5±√812
x=5±√812
x=5±92
x={5+92=142=75−92=−42=−2
Quindi il dominio della funzione è
Df=(−∞,−2)∪(−2,7)∪(7,∞)
Il punto x=-2 è un punto di accumulazione della funzione.
Quindi, posso procedere con il calcolo del limite.
Il limite è una forma indeterminata 0/0
limx→−23x2+x−10x2−5x−14=00
Per evitare la forma indeterminata, provo a riscrivere la funzione in una forma equivalente.
Applico il metodo di Ruffini per semplificare il polinomio al numeratore.
31-10−2−6+103−50
Quindi il numeratore posso riscriverlo (x+2)(3x-5)
limx→−2(x+2)(3x−5)x2−5x−14
Applico di nuovo il metodo di Ruffini per semplificare il polinomio al denominatore.
1-5-14−2−2141−70
Quindi il numeratore posso riscriverlo (x+2)(x-7)
limx→−2(x+2)(3x−5)(x+2)(x−7)
Elimino (x+2) al numeratore e al denominatore
limx→−23x−5x−7
Quindi, calcolo il limite per x→-2
limx→−23x−5x−7=−11−9=119
Il limite della funzione è 11/9.
Nota. Essendo una forma indeterminata 0/0 potrei risolvere la forma indeterminata anche usando il teorema di L'Hopital. limx→−23x2+x−10x2−5x−14 limx→−2D[3x2+x−10]D[x2−5x−14] La derivata del polinomio al numeratore è D[3x2+x-10]=6x+1 mentre la derivata del polinomio al denominatore è D[x2-5x-14]=2x-5. limx→−26x+12x−5 Poi calcolo il limite per x→-2. limx→−26x+12x−5=−11−9=119 Il risultato è lo stesso.
Esercizio 13
Devo studiare il limite
limx→2√x2−2x+9−3x3−x2−x−2
Riscrivo il denominatore della funzione in una forma equivalente usando il metodo di Ruffini
1-1-1-222221110
Quindi il denominatore diventa
limx→2√x2−2x+9−3(x−2)⋅(x2+x+1)
In questa forma è più facile capire il dominio della funzione fratta.
Il dominio della funzione è l'insieme dei numeri reali ad eccezione dei punti in cui si annulla il denominatore.
Df=R−{2}
Il punto x=2 è un punto di accumulazione della funzione.
Quindi, posso procedere con il calcolo del limite.
Il limite è però una forma indeterminata del tipo 0/0
limx→2√x2−2x+9−3(x−2)⋅(x2+x+1)=00
Per uscire dalla forma indeterminata, razionalizzo il denominatore moltiplicando e dividendo per
limx→2√x2−2x+9−3(x−2)⋅(x2+x+1)⋅√x2−2x+9+3√x2−2x+9+3
limx→2(x2−2x+9)−9(x−2)⋅(x2+x+1)⋅(√x2−2x+9+3)
limx→2x2−2x(x−2)⋅(x2+x+1)⋅(√x2−2x+9+3)
limx→2x⋅(x−2)(x−2)⋅(x2+x+1)⋅(√x2−2x+9+3)
Elimino (x-2) al numeratore e al denominatore.
limx→2x(x2+x+1)⋅(√x2−2x+9+3)
Ora il limite è calcolabile per x→2.
limx→2x(x2+x+1)⋅(√x2−2x+9+3)=2(7⋅6)=121
Il limite della funzione è 1/21.
Esercizio 14
Devo studiare il limite
limx→−1√x2+3−23−√8−x3
Il dominio della funzione è
Df=(∞,−1)∪(−1,2)
Il punto x=-1 è un punto di accumulazione della funzione.
Quindi, posso procedere con il calcolo del limite.
Tuttavia, il limite per x->-1 è una forma indeterminata del tipo 0/0
limx→−1√x2+3−23−√8−x3=00
Per uscire dalla forma indeterminata, razionalizzo il numeratore
limx→−1√x2+3−23−√8−x3⋅√x2+3+2√x2+3+2
limx→−1√x2+3−2(3−√8−x3)⋅(√x2+3+2)⋅√x12+3+2
limx→−1√x2+3⋅√x2+3+2√x2+3−2√x2+3−2⋅2(3−√8−x3)⋅(√x2+3+2)
limx→−1(x2+3)−4(3−√8−x3)⋅(√x2+3+2)
limx→−1x2−1(3−√8−x3)⋅(√x2+3+2)
limx→−1(x2+3)−43−√8−x3⋅1√x2+3+2
limx→−1x2+3−43−√8−x3⋅limx→−11√x2+3+2
Il secondo limite converge a 1/4
[limx→−1x2−13−√8−x3]⋅14
14⋅limx→−1x2−13−√8−x3
Ora razionalizzo il denominatore
14⋅limx→−1x2−13−√8−x3⋅3+√8−x33+√8−x3
14⋅limx→−1(x2−1)⋅(3+√8−x3)(3−√8−x3)⋅(3+√8−x3)
14⋅limx→−1(x2−1)⋅(3+√8−x3)3⋅3+3⋅√8−x3−3⋅√8−x3−√8−x3⋅√8−x3
14⋅limx→−1(x2−1)⋅(3+√8−x3)9−(8−x3)
14⋅limx→−1(x2−1)⋅(3+√8−x3)9−8+x3
14⋅limx→−1(x2−1)⋅(3+√8−x3)1+x3
Al numeratore c'è una differenza di quadrati (a2-b2)=(a-b)(a+b)
14⋅limx→−1(x−1)⋅(x+1)⋅(3+√8−x3)1+x3
Al denominatore c'è una somma di cubi (a3+b3)=(a+b)(a2-ab+b2)
14⋅limx→−1(x−1)⋅(x+1)⋅(3+√8−x3)(x+1)⋅(1−x+x2)
Elimino (x+1) al numeratore e al denominatore
14⋅limx→−1(x−1)⋅(3+√8−x3)1−x+x2
Ora anche il secondo limite è calcolabile per x→-1
14⋅(−2)⋅(6)1−x+x2
14⋅limx→−1(x−1)⋅(3+√8−x3)1−x+x2
=14⋅(−2)⋅(6)3
=−1212
=−1
Il limite della funzione è -1
Esercizio 15
Devo studiare il limite
limx→0sin(x)x
Il limite è una forma indeterminata del tipo 0/0
Si tratta di uno dei più importanti limiti notevoli.
Per risolvere il limite sostituisco la funzione trascendente sin(x) con il polinomio algebrico ottenuto usando la formula di MacLaurin di ordine 1 per x→0
sin(x)=x+o[x1]
Sostituisco sin(x)=x+o[x]
limx→0sin(x)x
limx→0x+o[x]x
Per la proprietà degli o piccoli o[x]=x·o[1]
limx→0x+x⋅o[1]x
Metto in evidenza la x e semplifico
limx→0x(1+o[1])x
limx→01+o[1]
1+limx→0o[1]
La funzione o[1] è una funzione infinitesima ossia prossima a zero per x→0
1+0
Pertanto, il limite della funzione per x→0 è uguale a uno.
limx→0sin(x)x=1
Esercizio 16
Devo risolvere il limite
limx→0sin(3x)x
Questo limite somiglia molto al limite notevole
limx→0sin(x)x=1
Avevo già visto questo limite almeno cinque volte. In teoria lo conoscevo a memoria:
Eppure ogni volta che lo incontravo in mezzo ad altri passaggi, lo saltavo o sbagliavo. Perché? Perché non lo vedevo. Non lo riconoscevo mascherato in un'altra espressione.
Inoltre, spesso ci si dimentica che il limite notevole può essere esteso al caso generale sin(kx)/kx→1 solo se al denominatore c’è lo stesso argomento che sta dentro il seno.
Quindi, per risolvere questo esercizio mi basta riscrivere l'espressione in una forma equivalente.
Ad esempio, divido e moltiplico per tre.
limx→0sin(3x)x
limx→0sin(3x)x⋅33
limx→0sin(3x)3x⋅3
3⋅limx→0sin(3x)3x
Ora il limite notevole è ben evidente sin(kx)/kx→1 dove k=3.
3⋅limx→0sin(3x)3x=3⋅1
Pertanto, la soluzione è
limx→0sin(3x)x=3
In conclusione, non basta sapere che il limite notevole è sin(x)/x→1, bisogna anche riconoscerlo anche quando è camuffato.
Il trucco è di portare sempre il denominatore a somigliare all’argomento del seno, o viceversa.
Esercizio 17
In questo esercizio devo risolvere il limite
limx→0√1+x−1x
Che tipo di limite è? È una forma indeterminata 00, perché sia il numeratore che il numeratore tendono a zero per x→0.
Quindi devo risolverlo usando qualche trasformazione.
Ad esempio, posso trasformare la differenza di radicali in una differenza di quadrati, cioè in un’espressione senza radici.
Moltiplico numeratore e denominatore per il coniugato del numeratore:
limx→0√1+x−1x⋅√1+x+1√1+x+1
Ora al numeratore c'è una differenza di quadrati (a+b)(a−b)=a2−b2
limx→0(√1+x)2−(1)2x√1+x+1
limx→0(1+x)−1x(√1+x+1)
limx→0xx(√1+x+1)
Quindi l'espressione si semplifica:
limx→01√1+x+1
A questo punto il limite si risolve facilmente perché è diventato un caso elementare.
limx→01√1+x+1=11+1=12
Il limite della funzione è 1/2.
Esercizio 18
Devo studiare il limite
limx→01−cos(3x)x2
Questo limite somiglia al limite notevole limx→01−cos(x)x2=12
Per ricondurlo a questa forma introduco una variabile temporanea u=3x
limx→01−cos(u)x2
Quando x→0 va a zero, anche u→0, quindi cambio anche la variabile del limite.
limu→01−cos(u)x2
Sapendo che u=3x allora x=u3, quindi sostituisco anche la variabile x al denominatore.
limu→01−cos(u)(u3)2
limu→01−cos(u)u29
limu→01−cos(u)u2⋅9
Faccio uscire la costante 9 dal limite.
9⋅limu→01−cos(u)u2
A questo punto posso applicare il limite notevole limu→01−cos(u)u2=12
9⋅limu→01−cos(u)u2=9⋅12=92
Quindi, il risultato del limite è il seguente:
limx→01−cos(3x)x2=92
Esercizio 19
Devo studiare il limite
limx→0sin(x)−xx3
Il limite è una forma indeterminata del tipo 0/0
Per risolverlo sostituisco la funzione trascendente sin(x) con il polinomio algebrico ottenuto usando la formula di MacLaurin di ordine 3 per x→0
sin(x)=x−x33!+o[x3]
sin(x)=x−x33⋅2⋅1+o[x3]
sin(x)=x−x36+o[x3]
Nota. Utilizzo la formula di MacLaurin ordine 3 perché la funzione nel limite ha un polinomio di grado 3 al denominatore.
Sostituisco sin(x)=x-x3/6+o[x3]
limx→0sin(x)−xx3
limx→0[x−x36+o[x3]]−xx3
limx→0−x36+o[x3]x3
Per la proprietà degli o piccoli o[x3]=x3 ·o[1]
limx→0−x36+x3⋅o[1]x3
Metto in evidenza la x e semplifico
limx→0x3⋅(−16+o[1])x3
limx→0−16+o[1]
−16+limx→0o[1]
La funzione o[1] è una funzione infinitesima ossia prossima a zero
−16+0
Pertanto, il limite della funzione per x→0 è uguale a meno un sesto.
limx→0sin(x)−xx3=−16
Esercizio 20
Devo studiare il limite
limx→01−cos(x)x2
Il limite è una forma indeterminata del tipo 0/0
limx→01−cos(x)x2=00
Può essere risolto in vari modi
Soluzione con MacLaurin
Si tratta di limite per x che tende a zero.
Quindi, per risolvere il limite posso usare la formula di MacLaurin
limx→01−cos(x)x2
Sostituisco la funzione trascendente del coseno con un polinomio di ordine 2 tramite la formula di MacLaurin
cos(x)=1−x22+o[x2]
Scelgo la formula di ordine 2 per semplificare il polinomio di secondo grado che si trova al denominatore della funzione
Sostituisco la funzione trascendente con il polinomio 1-x2/2+o[x2]
limx→01−(1−x22+o[x2])x2
limx→01−1+x22−o[x2]x2
limx→0x22−x2⋅o[1]x2
limx→0x2⋅(12−o[1])x2
limx→012−o[1]1
limx→012−o[1]=12
Quindi il limite è uguale a 1/2.
Soluzione con De L'Hopital
Per risolvere il limite posso anche usare il teorema di De L'Hopital
limx→01−cos(x)x2
Derivo il numeratore e il denominatore
limx→0D[1−cos(x)]D[x2]
limx→0sin(x)]2x=00
E' ancora una forma indeterminata.
Quindi reitero il teorema di De L'Hopital
limx→0D[sin(x)]D[2x]
limx→0cos(x)2=12
Quindi, il limite della funzione è 1/2
Soluzione con la trigonometria
Per risolvere questo limite
limx→01−cos(x)x2
Uso la formula di duplicazione del coseno
cos2a=1−2sin2a
In questo caso x=2a, quindi a=x/2
cosx=1−2sin2x2
Sostituisco il coseno nel limite
limx→01−[1−2sin2x2]x2
limx→01−1+2sin2x2x2
limx→02sin2x2x2
2limx→0(sinx2x)2
Per applicare il limite notevole sin(a)/a = 1 moltiplico e divido per 2 il denominatore
2limx→0(sinx2x⋅22)2
2limx→0(sinx22⋅x2)2
2limx→014⋅(sinx2x2)2
2⋅14limx→0(sinx2x2)2
12limx→0(sinx2x2)2
Sapendo che il limite notevole sin(a)/a = 1 con a=x/2
12⋅1
Quindi il limite della funzione è 1/2
Esercizio 21
Devo risolvere il limite
limx→0cos(x)−1x
Si tratta di una forma indeterminata 0/0
limx→0cos(x)−1x=00
Per uscire dalla forma indeterminata e risolvere il limite posso seguire diverse strade
Soluzione con MacLaurin
Per risolvere il limite
limx→0cos(x)−1x
Sostituisco la funzione coseno con il polinomio di MacLaurin del coseno di ordine 2
cos(x)=1−x22!+o[x2]
Dopo la sostituzione il limite diventa
limx→0(1−x22!+o[x2])−1x
Semplifico
limx→01−x22⋅1−1+o[x2]x
limx→0x22+x2⋅o[1]x
limx→0x2+x⋅o[1]1
limx→0x2+x⋅o[1]=0
Quindi, il limite della funzione è zero.
Nota. Per risolvere il limite avrei potuto usare anche il polinomio di MacLaurin del coseno di ordine 1. cos(x)=1+o[x] Il risultato sarebbe stato lo stesso.
Soluzione con De L'Hopital
Per risolvere il limite
limx→0cos(x)−1x
utilizzo il teorema di De L'Hopital
Derivo il numeratore e il denominatore della funzione fratta
limx→0D[cos(x)−1]D[x]
limx→0−sin(x)1
limx→0−sin(x)=0
Il limite è uguale a zero.
Soluzione alternativa
Questo limite si può risolvere anche in un altro modo
limx→0cos(x)−1x
Sapendo che cos(0)=1, il limite precedente è paragonabile al limite di un rapporto incrementale con a=0 e f(x)=cos(a)
limx→af(x)−f(a)x−a=f′(x)
limx→0cos(x)−cos(0)x−0=f′(x)
Quindi il limite coincide con la derivata prima della funzione f(x)=cos(x).
limx→0cos(x)−cos(0)x−0=D[cos(x)]
La derivata prima della funzione coseno è -sin(x)
limx→0cos(x)−cos(0)x−0=−sin(x)
Sapendo che sin(x)=0 per x che tende a zero
limx→0cos(x)−cos(0)x−0=0
Pertanto, il limite della funzione è uguale a 0.
Soluzione con i limiti notevoli
Questo limite si può risolvere anche con i limiti notevoli
limx→0cos(x)−1x
Moltiplico e divido per x
limx→0cos(x)−1x⋅xx
limx→0cos(x)−1x2⋅x
Riscrivo il limite in questa forma algebrica equivalente
limx→0(−1)⋅1−cos(x)x2⋅x
−1⋅limx→01−cos(x)x2⋅x
Sapendo che [1-cos(x)]/x2 è un limite notevole uguale a 1/2
−1⋅limx→01−cos(x)x2⋅x=−12⋅0=0
Il limite è uguale a zero.
Esercizio 22
Devo risolvere il limite
limx→π4tan(x)−1x−π4
La tangente di π/4 (45°) è uguale a 1
tan(π4)=1
Quindi, il limite è una forma indeterminata 0/0
limx→π4tan(x)−1x−π4=00
Sapendo che tan(π/4)=1, mi accorgo che il limite è paragonabile al limite di un rapporto incrementale con a=π/4 e f(x)=tan(a)
limx→af(x)−f(a)x−a=f′(x)
limx→π4tan(x)−tan(π4)x−π4=f′(x)
Il limite del rapporto incrementale è la derivata f'(x)
Quindi il limite coincide con la derivata prima della funzione f(x)=tan(x).
limx→pi4tan(x)−tan(π4)x−π4=D[tan(x)]
La derivata prima della tangente è 1/cos2(x)
limx→pi4tan(x)−tan(π4)x−π4=1cos2(x)
Per x che tende a π/4, il coseno di π/4 è uguale (√2)/2
limx→π4tan(x)−tan(π4)x−π4=1(√22)2
limx→π4tan(x)−tan(π4)x−π4=124
limx→π4tan(x)−tan(π4)x−π4=112
limx→π4tan(x)−tan(π4)x−π4=2
Pertanto, il limite della funzione è uguale a 2.
Verifica. Il limite è risolvibile anche con il teorema di De L'Hopital. limx→π4tan(x)−1x−π4 Derivo il numeratore e il denominatore. limx→π4D[tan(x)−1]D[x−π4] limx→π41cos2(x)1=limx→π41cos2(x) Per x che tende a π/4, il coseno di π/4 è uguale (√2)/2 limx→π41cos2(x)=1(√22)2=124=1⋅42=2 Il risultato è lo stesso.
Esercizio 23
Devo studiare il limite
limx→0sinxex−1
Questo limite genera una forma indeterminata del tipo 0/0
Per risolvere il limite sostituisco le funzioni trascendenti sin(x) ed ex con i polinomi algebrici ottenuti usando la formula di MacLaurin di ordine 1 per x→0
sin(x)=x+o[x]
ex=1+x+o[x]
Sostituisco sin(x)=x+o[x]
limx→0sinxex−1
limx→0x+o[x]ex−1
Sostituisco ex=1+x+o[x]
limx→0x+o[x][1+x+o[x]]−1
limx→0x+o[x]x+o[x]
Per la proprietà degli o piccoli o[x]=x·o[1]
limx→0x+x⋅o[1]x+x⋅o[1]
Metto in evidenza la x e semplifico
limx→0x⋅(1+o[1])x⋅(1+o[1])
limx→01+o[1]1+o[1]
Le funzioni o[1] sono funzioni infinitesime che tendono a zero per x→0
limx→01+o[1]1+o[1]=11=1
Pertanto, il limite della funzione per x→0 è uguale a uno.
Esercizio 24
In questo esercizio studio il limite per x che tende a 2 della funzione
limx→2√x2+5−√x3+12x−x2
Il limite è una forma indeterminata del tipo 0/0
limx→2√x2+5−√x3+12x−x2=00
Per rimuovere la forma indeterminata razionalizzo il numeratore
limx→2√x2+5−√x3+12x−x2⋅√x2+5+√x3+1√x2+5+√x3+1
limx→2√x2+5√x2+5−√x3+1√x3+12x−x2⋅1√x2+5+√x3+1
limx→2√(x2+5)2−√(x3+1)22x−x2⋅1√x2+5+√x3+1
limx→2x2+5−x3−12x−x2⋅limx→21√x2+5+√x3+1
limx→2x2−x3+42x−x2⋅limx→21√x2+5+√x3+1
Il secondo limite tende a 1/6
[limx→2x2−x3+42x−x2]⋅16
16⋅limx→2x2−x3+42x−x2
L'altro limite è ancora una forma indeterminata 0/0
Per uscirne semplifico il numeratore usando il metodo di Ruffini
16⋅limx→2x2−x3+42x−x2
16⋅limx→2(x−2)⋅(−x2−x−2)2x−x2
Nota. Usando il metodo di Ruffini il polinomio x2-x3+4 posso scriverlo nella forma equivalente (x-2)(-x2-x-2) -11042−2−2−4−1−1−20
Riscrivo il denominatore (2x-x2) in una forma equivalente (-x)·(x-2) per poter semplificare la frazione
16⋅limx→2(x−2)⋅(−x2−x−2)(−x)⋅(x−2)
Poi semplifico (x-2) al numeratore e al denominatore
16⋅limx→2(−x2−x−2)(−x)
Ora il limite è calcolabile ed è pari a 4
16⋅−8−2
16⋅4
46
23
Il limite della funzione è 2/3.
Esercizio 25
In questo esercizio devo calcolare il limite per x che tende a 0 della funzione
limx→03−√9−x22√1+x2−√4+x2
Il punto x=0 è un punto di accumulazione appartenente al dominio della funzione.
Il limite è una forma indeterminata del tipo 0/0
limx→03−√9−x22√1+x2−√4+x2=00
Rimuovo la forma indeterminata razionalizzando il denominatore
limx→03−√9−x22√1+x2−√4+x2⋅2√1+x2+√4+x22√1+x2+√4+x2
limx→0(3−√9−x2)⋅(2√1+x2+√4+x2)2√1+x2⋅2√1+x2−√4+x2⋅√4+x2
limx→0(3−√9−x2)⋅(2√1+x2+√4+x2)4(1+x2)−(4−x2)
limx→0(3−√9−x2)⋅(2√1+x2+√4+x2)4+4x2−4−x2
limx→0(3−√9−x2)⋅(2√1+x2+√4+x2)3x2
limx→03−√9−x23x2⋅(2√1+x2+√4+x2)
limx→03−√9−x23x2⋅limx→0(2√1+x2+√4+x2)
Il secondo limite tende a 4
[limx→03−√9−x23x2]⋅4
4⋅limx→03−√9−x23x2
L'altro limite è ancora una forma indeterminata 0/0
A questo punto razionalizzo il numeratore
4⋅limx→03−√9−x23x2⋅3+√9−x23+√9−x2
4⋅limx→03⋅3+3√9−x2−3√9−x2−√9−x2√9−x23x2⋅(3+√9−x2)
4⋅limx→09−(9−x2)3x2⋅(3+√9−x2)
4⋅limx→09−9+x23x2⋅(3+√9−x2)
4⋅limx→0x23x2⋅(3+√9−x2)
Elimino x2 al numeratore e al denominatore
4⋅limx→013⋅(3+√9−x2)
Ora anche l'altro limite è calcolabile
4⋅limx→013⋅(3+√9−x2)=4⋅118=29
Pertanto, il limite della funzione è 2/9.
Esercizio 26
Devo studiare questo limite per x che tende a zero
limx→0(e3x−1)sinx4x2log(1+x3)
Il limite è una forma indeterminata del tipo 0/0
limx→0(e3x−1)sinx4x2log(1+x3)=00
Per uscire dalla forma indeterminata riscrivo il limite in questa forma equivalente
limx→0(e3x−1)x⋅sinx4xlog(1+x3)=
limx→0(e3x−1)x⋅limx→0sinx4xlog(1+x3)
Moltiplico e divido il primo limite per 3
limx→0(e3x−1)x⋅33⋅limx→0sinx4xlog(1+x3)
3⋅limx→0(e3x−1)3x⋅limx→0sinx4xlog(1+x3)
In questo modo ottengo il limite notevole (et-1)/t=1 dove t=3x
3⋅[1]⋅limx→0sinx4xlog(1+x3)
3⋅limx→0sinx4xlog(1+x3)
Ora moltiplico e divido per x3 il denominatore dell'altro limite
3⋅limx→0sinx4xlog(1+x3)⋅x3x3
3⋅limx→0sinx4x4⋅log(1+x3)x3
3⋅[limx→0sinx4x4⋅limx→01log(1+x3)x3]
In questo modo ottengo altri due limiti notevoli
Il primo limite notevole è sin(t)/t=1 dove t=x4
3⋅[1⋅limx→01log(1+x3)x3]
3⋅limx→01log(1+x3)x3
L'ultimo limite notevole è log(t+1)/t=1 dove t=x3
3⋅limx→01log(1+x3)x3=3⋅11=3
Quindi il limite per x->0 è 3.
Esercizio 27
Devo calcolare il limite di x+sin(x)x−cos(x) per x→∞.
limx→∞x+sin(x)x−cos(x)
Per farlo posso seguire diverse strade.
In questo caso non posso utilizzare il teorema di De L'Hopital perché anche se il limite è una forma indeterminata del tipo ∞∞, il limite delle derivate non è finito ma oscilla tra 0 e infinito. limx→∞f′(x)g′(x)=limx→∞1+cos(x)1+sin(x)
Soluzione 1
Posso semplificare la frazione dividendo numeratore e denominatore per x.
limx→∞x+sin(x)x−cos(x)
limx→∞x+sin(x)xx−cos(x)x
limx→∞xx+sin(x)xxx−cos(x)x
limx→∞1+sin(x)x1−cos(x)x
Ora, osservo che sia sin(x)x che cos(x)x tendono a 0 quando x tende a ∞, perché sin(x) e cos(x) sono funzioni limitate (compresi tra -1 e 1) ma x tende a infinito.
Quindi posso risolvere il limite perché sia il numeratore che il denominatore tendono a 1.
limx→∞1+sin(x)x1−cos(x)x=1+01−0=11=1
Pertanto, il limite di x+sin(x)x−cos(x) per x→∞ è 1.
limx→∞x+sin(x)x−cos(x)=1
Soluzione 2
Posso studiare il limite di x+sin(x)x−cos(x) per x→∞ anche usando il teorema dei carabinieri (o del confronto)
limx→∞x+sin(x)x−cos(x)
Devo trovare due funzioni che limitano la funzione.
f(x)=x+sin(x)x−cos(x)
Sia sin(x) che cos(x) sono funzioni limitate tra -1 e 1 per ogni x.
−1≤sin(x)≤1
−1≤cos(x)≤1
Quindi, posso trovare i limiti superiori e inferiori per f(x):
x−1x+1≤x+sin(x)x−cos(x)≤x+1x−1
Ora calcolo il limite per x che tende a infinito di ogni termine
limx→∞x−1x+1≤limx→∞x+sin(x)x−cos(x)≤limx→∞x+1x−1
A questo punto considero i limiti di queste due funzioni quando x tende a ∞:
limx→∞1−1x1+1x≤limx→∞x+sin(x)x−cos(x)≤limx→∞1+1x1−1x
1−01+0≤limx→∞x+sin(x)x−cos(x)≤1+01−0
1≤limx→∞x+sin(x)x−cos(x)≤1
Secondo il teorema dei carabinieri, se una funzione è limitata superiormente e inferiormente da due funzioni che tendono allo stesso limite, allora anche la funzione data tenderà a quel limite.
In questo caso sia il limite inferiore che superiore sono uguali a 1.
1≤limx→∞x+sin(x)x−cos(x)≤1
Quindi, posso concludere che anche il limite della funzione iniziale è uguale a 1
limx→∞x+sin(x)x−cos(x)=1
E così via.