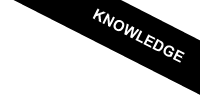Fisica delle particelle
La fisica delle particelle studia i costituenti più piccoli della materia. Non si occupa di molecole, né di atomi, ma di ciò che sta al di sotto: quark, elettroni, neutrini, fotoni e altri componenti elementari.
Le particelle subatomiche elementari hanno in comune di essere oggetti perfetti. Queste particelle sono identiche tra loro.
Ad esempio, un elettrone è uguale a qualsiasi altro elettrone, ovunque nell’universo. Non ci sono elettroni grandi o piccoli, vecchi o nuovi.
Questa proprietà rende la fisica delle particelle molto diversa dalle scienze che studiano oggetti macroscopici.
Nota. A differenza di una macchina o di una cellula, una particella elementare non ha parti interne, non può essere distinta dalle sue copie. Non esistono imperfezioni. Questo semplifica lo studio: una volta che conosci le proprietà di un elettrone, le conosci per tutti. Ad esempio, se osserviamo il decadimento di un muone, possiamo replicarlo in laboratorio migliaia di volte. Il risultato sarà sempre lo stesso. Questo permette di dedurre le leggi fisiche che governano il processo.
Nell'infinitamente piccolo le particelle non si possono manipolare direttamente e non si possono toccare con strumenti fisici.
Per analizzarle, si usano tre metodi principali:
- Scattering (urti): si fa collidere una particella contro un’altra e si osserva la deviazione.
- Decadimento: si analizzano i prodotti quando una particella si disintegra spontaneamente.
- Stati legati: si studiano sistemi composti da più particelle, come il protone o il neutrone.
La fisica classica non è in grado di descrivere in modo adeguato i fenomeni che coinvolgono le particelle elementari.
La meccanica classica spiega bene la gravità e le forze tra oggetti macroscopici, ma non basta quando si tratta del comportamento della materia su scala subatomica.
Per comprendere le particelle, è necessario ricorrere a due teorie fondamentali:
- La meccanica quantistica, che introduce il concetto di probabilità e descrive il comportamento delle particelle estremamente piccole.
- La relatività ristretta, che spiega ciò che accade quando i corpi si muovono a velocità prossime a quella della luce.
Poiché le particelle elementari sono sia piccolissime sia spesso dotate di velocità molto elevate, è indispensabile tener conto di entrambe le teorie.
La loro integrazione ha portato alla nascita della teoria quantistica dei campi, il quadro teorico di riferimento in cui si sviluppa la fisica delle particelle.
Pertanto, la teoria dei campi studia le particelle infinitamente piccole quando si muovono ad alte velocità, prossime alla velocità della luce.
Il Modello Standard (SL)
Attualmente le interazioni fondamentali tra le particelle, tranne la gravità, sono spiegate dal Modello Standard (SL).
Tutte le interazioni sono descritte attraverso un principio comune: l’invarianza di gauge.
Nota. Il bosone di Higgs, previsto dal Modello Standard, è stato scoperto nel 2012. Senza di esso, le particelle non avrebbero massa. La sua osservazione sperimentale ha confermato la validità della teoria.
Il Modello Standard è un capolavoro della fisica moderna, ma è incompleto
È una teoria estremamente precisa e ha superato quasi tutti i test sperimentali disponibili, ma presenta limiti ben noti.
Spiega le tre interazioni fondamentali (elettromagnetica, debole e forte), ma non include la gravità, non fornisce risposte sulla materia oscura, l’energia oscura o l’origine della massa dei neutrini.
In altre parole, il Modello Standard è come una mappa dettagliata ma parziale della realtà: mostra con precisione ciò che conosciamo, ma lascia in bianco aree ancora inesplorate dell’universo.
Il compito della fisica teorica oggi è proprio questo: andare oltre il Modello Standard.
Gli scienziati sospettano che il Modello Standard sia solo una parte di una teoria più ampia, chiamata genericamente "nuova fisica".
La storia
Nel V secolo a.C., Leucippo e Democrito introdussero per la prima volta l’idea che la materia fosse composta da particelle indivisibili, chiamate atomos, termine greco che significa “non tagliabile”.
In questo contesto, l’atomo non era un’entità sperimentale, ma una costruzione logica per spiegare il cambiamento e la permanenza nella natura. E per quasi due millenni, l’idea di atomo rimase filosofica.
Solo nel XIX secolo, con lo sviluppo della chimica moderna, l’atomo venne considerato come una unità reale e indivisibile della materia.
La crisi dell’indivisibilità
Nel 1897, J.J. Thomson scoprì l’elettrone, una particella con carica negativa presente in tutti gli atomi.
Questo esperimento, basato sul comportamento dei raggi catodici, rivelò che l’atomo non era indivisibile, ma possedeva una struttura interna.
L’elettrone fu identificato come responsabile delle correnti elettriche nei metalli.
Il nucleo e le particelle subatomiche
Nel 1911 Ernest Rutherford, con l’esperimento della lamina d’oro, mostrò che la massa dell’atomo era concentrata in un nucleo positivo molto piccolo, attorno al quale orbitavano gli elettroni.
Il protone venne identificato come la particella che conferiva carica positiva al nucleo.
La scoperta del neutrone
Nel 1932 James Chadwick scoprì il neutrone, privo di carica elettrica ma dotato di massa, risolvendo il problema della massa mancante nel nucleo.
Ad esempio, il nucleo dell’elio è composto da 2 protoni e 2 neutroni.
L’antimateria e la fisica delle particelle
Negli anni '30 Carl Anderson osservò una particella identica all’elettrone ma con carica opposta: il positrone.
Era la prima evidenza sperimentale dell’antimateria.
Ci si accorse che un positrone e un elettrone annichiliscono, emettendo due fotoni gamma.
Poco dopo fu ipotizzata anche l'esistenza degli anti-protoni e degli anti-neutroni.
I quark
Negli anni '60 si iniziò a ipotizzare che protoni e neutroni non fossero davvero elementari, ma composti da particelle più piccole, i quark.
Le prime evidenze emersero negli esperimenti di scattering profondo condotti allo SLAC.
La nascita del Modello Standard
Negli anni '70 le particelle elementari vennero suddivise in due classi:
- Fermioni (materia): quark e leptoni (es. elettrone, neutrino)
- Bosoni (forze): fotone (interazione elettromagnetica), gluone (interazione forte), bosoni W e Z (interazione debole)
Il bosone di Higgs
Il 4 luglio 2012, gli esperimenti ATLAS e CMS al CERN annunciarono l’osservazione del bosone di Higgs con una massa di circa 125 GeV/c*.
Questa particella spiega l’origine della massa di molte altre particelle attraverso il cosiddetto meccanismo di Higgs.
Oltre il Modello Standard
Il Modello Standard, pur essendo una teoria estremamente accurata, presenta gravi lacune:
- Non include la gravità
- Non spiega il numero di famiglie di particelle
- Ignora la materia oscura e l’energia oscura
- Richiede parametri arbitrari, come le masse delle particelle.
Oggi diverse proposte e teorie speculative cercano di estendere il Modello Standard.
Ad esempio, secondo la supersimmetria (SUSY) ogni particella ha un "superpartner". Si ipotizza l'esistenza del "gravitone", un ipotetico bosone mediatore della gravità. Secondo la teoria delle stringhe le particelle sono “vibrazioni” di stringhe unidimensionali. Si ipotizza anche l'esistenza dei preoni, subunità più fondamentali dei quark e leptoni.
Tuttavia, attualmente nessuna di queste teorie speculative è stata confermata sperimentalmente.
La struttura ultima della materia resta ancora un enigma. Non sappiamo se esistono ancora livelli più profondi della materia, oppure siamo vicini ai mattoni fondamentali dell’universo.
I rivelatori di particelle
Il rilevamento delle particelle si basa sull’interazione tra la particella e un mezzo attraversato (es. vapore, gas, liquido, ecc.). Le particelle cariche lasciano tracce ionizzanti, mentre le particelle neutre devono essere identificate indirettamente tramite le interazioni secondarie.
Per individuare le particelle elementari si utilizzano degli appositi sistemi detti rivelatori di particelle che permettono di osservare e registrare il passaggio delle particelle subatomiche.
La rivelazione avviene trasformando l'interazione della particella con un mezzo in un segnale fisico misurabile: luce, carica elettrica, vapore condensato, ecc.
Come funzionano?
La maggior parte dei rivelatori si basa sulla ionizzazione del mezzo da parte della particella.
Quando una particella carica attraversa un materiale, urta gli atomi e strappa elettroni dagli orbitali più esterni.
Il risultato è la formazione di ioni positivi ed elettroni liberi, che possono essere usati per generare un segnale.
Ad esempio, le camere a nebbia utilizzano il vapore d’alcol sovrasaturo come mezzo, gli ioni fungono da nuclei di condensazione che tracciano delle scie di goccioline visibili. Le camere a bolle utilizzano un liquido surriscaldato (es. idrogeno liquido) come mezzo e la ionizzazione innesca la formazione di alcune scie di bolle. Le camere a scintilla usano un gas tra elettrodi come mezzo e la ionizzazione genera una scarica tra gli elettrodi ossia delle scintille ecc.
Tuttavia, i sistemi basati sulla ionizzazione hanno un limite: funzionano solo per particelle cariche. Non rivelano direttamente le particelle neutre.
Le particelle neutre (es. neutroni, neutrini) non ionizzano direttamente il mezzo, di conseguenza non lasciano traccia nei rivelatori basati su ionizzazione.
Per rilevarle si utilizzano altri metodi indiretti, si studiano le eventuali interazioni con le altre particelle.
Ad esempio, i neutroni si rivelano tramite urti elastici con nuclei leggeri (es. idrogeno) che generano protoni visibili. I neutrini si osservano indirettamente analizzando eventi secondari come il decadimento del muone o l’emissione di elettroni. In una camera a bolle, se un neutrino interagisce con un protone può produrre un muone, ecc.
Oltre ai metodi tradizionali, esistono anche rivelatori moderni basati su sistemi integrati composti da più sottorivelatori, ciascuno specializzato in un compito specifico.
Questi dispositivi combinano tecnologie differenti per analizzare ogni aspetto del passaggio delle particelle. I segnali prodotti sono sincronizzati e raccolti da computer, che ricostruiscono gli eventi e ne tracciano le traiettorie.
I rivelatori integrati consentono di rilevare sia particelle cariche, attraverso l’ionizzazione diretta, sia particelle neutre, mediante gli effetti secondari delle loro interazioni.
Le sorgenti delle particelle elementari
Per studiare le particelle elementari si utilizzano diverse fonti o sorgenti:
- Protoni ed elettroni
I protoni si ottengono facilmente ionizzando un atomo di idrogeno (H) mentre gli elettroni si ottengono riscaldando dei metalli (effetto termoionico), tramite l'effetto fotoelettrico o l'effetto di campo (emissione a campo intenso). - Decadimenti
E' il processo in cui una particella si disintegra spontaneamente emettendo delle particelle elementari (es. fotoni e neutrini). - Raggi cosmici
I raggi cosmici sono fonti naturali ideali per studiare le particelle. In gran parte i raggi cosmici sono composti da protoni, oltre che da nuclei di elio o nuclei più pesanti, elettroni, positroni e antiprotoni. Sono particelle ad altissima energia provenienti dallo spazio che generano anche sciami di particelle secondarie (muoni, pioni, neutrini...) nell’atmosfera. Tuttavia, sono flussi imprevedibili e la frequenza con cui colpiscono un rivelatore di particelle è molto bassa. - Sorgenti nucleari
I reattori nucleari producono neutrini elettronici in grandi quantità, neutroni e particelle alfa, beta (elettroni/positroni), gamma (fotoni). - Acceleratori di particelle
Producono particelle primarie (es. protoni, elettroni) e secondarie (es. pioni, muoni, kaoni, antiprotoni) tramite collisioni frontali ad alta energia (es. LHC, LEP) o meno (es. scattering). Lo scattering è il processo in cui due particelle si scontrano e interagiscono tra loro, modificando traiettoria, energia, o dando origine a nuove particelle. In particolar modo, gli acceleratori di particelle sono utili per studiare le nuove particelle instabili. Sono una fonte controllata, regolabile e riproducibile. Quindi, l'ideale per la ricerca.
E così via.