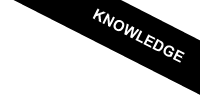Legge di esclusione tra solidi
La legge di esclusione stabilisce che tra due solidi A e B possono valere solo tre possibilità:
- A e B hanno lo stesso volume (sono equivalenti)
- A ha volume maggiore (prevalente) $ A>B $ o minore (subvalente) $ A <B $ rispetto a B.
Ogni caso esclude gli altri.
Si tratta di un postulato intuitivo che permette il confronto tra i solidi in base al volume.
Se un solido ha un volume maggiore di un altro, allora è prevalente. Viceversa è subvalente. Infine, se i due solidi hanno lo stesso volume sono solidi equivalenti.
Per una comprensione valida per la scuola media o superiore basta sapere questo senza leggere oltre.
Nota. Questo postulato appare semplice, ordinato e lineare. Ogni coppia di solidi si può confrontare e ordinare senza ambiguità. Ma questo vale solo nel mondo ideale della geometria astratta. Appena si esce da quel recinto, la realtà smentisce la linearità: non tutto è confrontabile, e non tutto si può ordinare. Spesso la realtà è complessa e non si lascia ridurre a un solo numero. Approfondisco il concetto nel paragrafo successivo.
La critica alla legge di esclusione
La legge di esclusione pretende di ordinare ogni coppia di solidi secondo il volume: equivalenti, prevalente o subvalente.
È una semplificazione elegante, ma pericolosa. Funziona solo nel vuoto astratto della geometria elementare, ma diventa fuorviante non appena si entra nel mondo reale, dove gli oggetti sono complessi e multidimensionali.
In altre parole, due solidi possono essere valutati con più criteri e non è detto che si riducano tutti a definire la stessa relazione d'ordine.
Esempio. Un cubo di marmo e un cubo di legno dello stesso volume. Secondo la legge, sarebbero equivalenti. Eppure, chi li solleva percepisce subito che non lo sono: il marmo pesa molto di più, è meno lavorabile, più costoso, più fragile, ha una densità diversa, ecc. Quindi, il volume non basta a definire un oggetto nella sua complessità.
Quando si adottano criteri multidimensionali, spesso i solidi diventano incommensurabili.
Dire che un solido è “prevalente” su un altro implica una superiorità. Ma superiore rispetto a cosa? Al peso? Alla superficie? Alla funzionalità? Alla resistenza? Alla bellezza? Non è chiaro.
Senza un criterio esplicitato, ogni confronto è privo di senso. Parlare di prevalenza in senso assoluto è come dire che una mela è migliore di un’arancia senza dire se parliamo di sapore, di vitamina C o di prezzo al chilo.
Esempio. Considero una sfera e un cubo con lo stesso volume. Sono solidi equivalenti. La sfera ha meno superficie ed è più efficiente nel ridurre la dissipazione di calore o nel muoversi nell’aria (pensiamo a una palla). Il cubo è più stabile, può essere impilato, usato per costruire. Inoltre, la sfera ha poco attrito e scivola facilmente mentre il cubo no. Quale è migliore? Il cubo o la sfera? Dipende da cosa devo fare.
L’illusione del confronto assoluto si infrange quando i criteri entrano in conflitto e non permettono un confronto chiaro.
E' lì che nasce l’incommensurabilità dei criteri, perché non esiste più un terreno comune per decidere chi è “più” o “meno”.
In conclusione, la legge di esclusione ha un valore didattico, utile per introdurre l’idea di confronto tra grandezze geometriche elementari e astratte. Ma pretendere che descriva la realtà in modo esaustivo è un errore.
In assenza di un contesto definito, ogni confronto assoluto è una semplificazione ingannevole, perché la realtà non è fatta per essere ordinata: è fatta per essere compresa.
E così via.