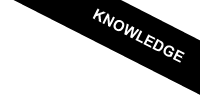Il tempo
Il tempo è la dimensione che usiamo per misurare il flusso degli eventi. Ci permette di collocarli in sequenza e di distinguere tra passato, presente e futuro.
Potrebbe sembrare un concetto banale ma non è così. Il tempo è anche una grandezza complessa e una fonte di discussioni filosofiche e scientifiche.
L'unità di misura del tempo
Il tempo viene misurato come l'intervallo tra due eventi, utilizzando fenomeni periodici come riferimento. L'unità di misura del tempo è il secondo (s).
Originariamente, il secondo era definito come una frazione del giorno solare medio, pari a 1/86.400 del giorno solare medio. Quindi, era basato sulla rotazione terrestre.
Tuttavia, poiché la rotazione della Terra non è regolare, venne deciso di adottare una definizione più accurata.
Dal 1967, il secondo è stato ridefinito come il tempo necessario affinché la radiazione emessa da un atomo di cesio-133 completi 9.192.631.770 oscillazioni.
Questa definizione, basata sugli orologi atomici, garantì una precisione estremamente elevata, fondamentale per numerose applicazioni scientifiche e tecnologiche.
Nota. Oggi, gli orologi atomici sono così precisi che accumulano un errore di solo un secondo ogni 60 milioni di anni. Il NIST-F1 è un orologio atomico a fontana di cesio, utilizzato come standard di riferimento per la misurazione del tempo negli Stati Uniti. Si trova presso il National Institute of Standards and Technology (NIST) a Boulder, in Colorado. Questo orologio atomico è tra i più precisi al mondo. Il suo funzionamento si basa su atomi di cesio-133 che vengono proiettati verso l'alto in una "fontana" e, mentre gli atomi salgono e ricadono, la loro frequenza di oscillazione viene misurata con estrema precisione.
Recentemente, orologi atomici ottici, che sfruttano la luce per misurare le oscillazioni atomiche, hanno raggiunto una precisione ancora maggiore, con un errore di circa un secondo ogni 15 miliardi di anni, superando di gran lunga i precedenti modelli a fontana di cesio.
Un orologio ottico ha un errore di circa 0,2 picosecondi (ps) al giorno.
Dal momento che 1 picosecondo equivale a \(10^{-12}\) secondi, posso calcolare quanti secondi perde un orologio ottico al giorno convertendo il valore:
$$ 0,2 \, \text{ps} = 0,2 \cdot 10^{-12} \, \text{secondi} = 2 \cdot 10^{-13} \, \text{secondi/giorno} $$
Quindi, un orologio ottico perde \( 2 \cdot 10^{-13} \) secondi al giorno, ovvero 0,0000000000002 secondi al giorno.
Nota. Sembra tanto? In realtà, questo errore è estremamente piccolo e conferma l'altissima precisione di questi dispositivi. Basti pensare che in 13,8 miliardi di anni, dal momento del Big Bang a oggi, un orologio atomico avrebbe perso circa 1 secondo. Per calcolare quanti secondi avrebbe perso un orologio ottico in 13,8 miliardi di anni, parto dall'errore giornaliero, che è di \( 2 \cdot 10^{-13} \) secondi al giorno, e lo moltiplico per il numero di giorni trascorsi dall'inizio dell'universo. \[
T = 13,8 \cdot 10^9 \, \text{anni} = 13,8 \cdot 10^9 \cdot 365 \, \text{giorni} \approx 5,04 \cdot 10^{12} \, \text{giorni}
\] Sapendo che l'errore giornaliero di un orologio atomico è \[ e_g = 2 \cdot 10^{-13} \, \text{secondi/giorno} \] L'errore accumulato in 13,8 miliardi di anni sarebbe pari a \[ e_T = e_g \cdot T = (2 \cdot 10^{-13}) \cdot (5,04 \cdot 10^{12}) \, \text{secondi} = 1,008 \, \text{secondi} \] In conclusione, un orologio ottico avrebbe perso circa 1 secondo in un periodo pari all'età dell'universo (13,8 miliardi di anni).
La storia del "tempo": dal tempo newtoniano al tempo relativo di Einstein
L'uomo si interroga sul tempo fin dagli albori della civiltà umana. Secondo il greco Eraclito il tempo scorre come un fiume ("Panta rei", tutto scorre) e nessuno ci si immerge due volte nello stesso punto.
Il tempo scorre ovunque. Concepire il tempo senza lo spazio è impossibile. Sono strettamente interconnessi.
Esempio. Il tempo scorre nello spazio, senza quest'ultimo non ci sarebbe movimento. D'altra parte, lo spazio senza il tempo non avrebbe senso.
Al di là dei ragionamenti filosofici, il tempo comincia a essere un tema scientifico a partire dal XV secolo, con l'inizio della rivoluzione scientifica.
Questo periodo segna il passaggio dal pensiero filosofico e religioso, che vede il tempo come un concetto astratto legato all'eternità e al movimento celeste, a una comprensione più pratica e misurabile del tempo.
Dal punto di vista scientifico, sia lo spazio che il tempo sono viste come grandezze fisiche in quanto sono misurabili, rispettivamente con il metro e con l'orologio.
Il tempo newtoniano è la prima concezione scientifica del tempo, introdotta da Isaac Newton nella sua meccanica classica.
In questo modello, il tempo è una grandezza assoluta, universale e scorre in modo uniforme per tutti, indipendentemente dal luogo, dagli eventi o dagli osservatori. Quindi, il tempo è considerato separato dallo spazio.
Questa visione è stata dominante fino al XX secolo, quando la teoria della relatività di Einstein ha dimostrato che il tempo è invece una grandezza relativa: varia in base alla velocità e alla gravità, ed è intrecciato con lo spazio, formando lo spazio-tempo.
Nota. Oggi sappiamo che lo spazio non è una grandezza assoluta e nemmeno il tempo lo è. Sia lo spazio che il tempo sono grandezze relative, legate una all'altra. Per questa ragione si parla di spazio-tempo.
La relatività del tempo
Il tempo non è una grandezza assoluta, generale e invariabile. In realtà, lo scorrere del tempo cambia a seconda del luogo in cui si trova, ossia il tempo è relativo.
La relatività del tempo venne scoperta da Albert Einstein agli inizi del '900 con la teoria della relatività. Secondo Einstein il tempo è influenzato dalle seguenti variabili:
- La velocità. Quanto maggiore è la velocità, tanto minore è lo scorrimento del tempo.
- Lo spazio. Il tempo e lo spazio sono strettamente collegati tra loro. Quando lo spazio si restringe, il tempo rallenta. Einstein parla di spazio-tempo come unica grandezza fisica di riferimento.
- La forza di gravità. La gravità può deflettere la luce e rallentare il tempo.
Esempio. Vicino a una stella il tempo scorre più lentamente rispetto alla Terra, perché la gravità/curvatura è maggiore.
Il paradosso dei due gemelli
E' un esempio classico per comprendere la relatività del tempo. In un tempo T due gemelli si salutano, uno dei due sta per partire in un razzo spaziale che viaggerà per sei mesi quasi alla velocità della luce.
Al suo ritorno sulla Terra, l'astronauta trova invecchiato di molti anni il suo fratello gemello.
Cos'è accaduto? Muovendosi a velocità elevata, il tempo dell'astronauta ha iniziato a rallentare ( C ).


Sulla Terra, invece, il tempo è continuato a scorrere normalmente ( A ).
Per questa ragione, al ritorno del suo viaggio l'astronauta trova il suo fratello gemello ormai vecchio, mentre lui è ancora giovane.
In pratica, durante i sei mesi di vita dell'astronauta a bordo del razzo spaziale sono trascorsi diversi anni sulla Terra.
Come si misura il tempo?
Sulla Terra, il tempo viene misurato attraverso fenomeni periodici, come l'anno solare o la regolarità del moto del pendolo.
Ma questo non vale ovunque nell'Universo, in generale per misurare il tempo bisogna considerare la velocità e la gravità.
Secondo Einstein il tempo non è uguale per tutti ma dipende dall'osservatore. Lo scorrere del tempo dipende dalla velocità dell'osservatore rispetto alla velocità della luce e dal punto dell'Universo in cui si trova.
La velocità della luce è costante. La luce si sposta nello spazio a 299 mila chilometri al secondo. E' uno dei limiti della fisica. Nessun oggetto o particella può muoversi a velocità superiore.
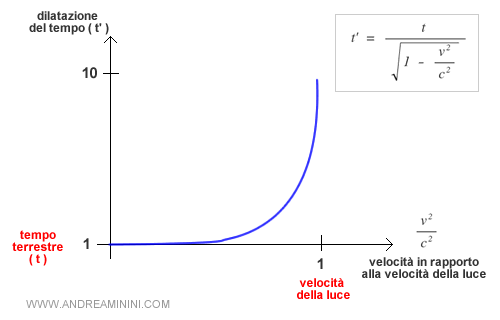
A velocità basse, la differenza è minima e il tempo scorre come pensava Newton, come una grandezza assoluta. A velocità prossime a quella della luce, invece, il tempo scorre molto più lentamente.
Inoltre, lo scorrere del tempo rallenta anche in presenza di una maggiore forza di gravità, come quella di una stella a neutroni o di un buco nero.
Pertanto, lo scorrere del tempo è un fenomeno relativo.