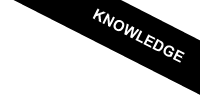La quantità di moto relativistica
La quantità di moto relativistica è definita come $$ \vec{p} = \gamma m \vec{v} $$ Dove $ \gamma $ è il fattore di Lorentz $$ \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} $$
La formula $ \vec{p} = \gamma m \vec{v} $ rappresenta la generalizzazione della quantità di moto classica ( $ \vec{p} = \vec{v} $ ) che tiene conto degli effetti della relatività ristretta.
Il fattore di Lorentz $ \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} $ aumenta rapidamente man mano che la velocità $ v $ si avvicina alla velocità della luce $ c $.
Questo significa che, anche se la massa $ m $ dell’oggetto resta la stessa, la quantità di moto relativistica $ \vec{p} = \gamma m \vec{v} $ cresce sempre di più al crescere di $ v $, diventando infinita quando $ v \to c $.
Per questa ragione, nessun corpo dotato di massa può mai raggiungere o superare la velocità della luce, perché servirebbe un’energia infinita.
$$ E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4 $$
Grazie a questa definizione corretta, la quantità di moto così calcolata si conserva in tutti i sistemi di riferimento inerziali, rispettando pienamente il principio di relatività.
Nota. La quantità di moto relativistica $ \vec{p} = \gamma m \vec{v} $ costituisce la parte spaziale del quadrivettore quantità di moto $$ P^\mu = (\gamma m c, \gamma m \vec{v}) = (\gamma m c, \gamma m v_x , \gamma m v_y , \gamma m v_z ) $$ Questo quadrivettore unifica in un’unica entità le nozioni di energia e di quantità di moto, facendo in modo che entrambe si conservino in tutti i sistemi di riferimento inerziali.
Spiegazione e dimostrazione
Nella meccanica classica, la quantità di moto (o momento lineare) è il prodotto tra la massa e il vettore velocità
$$ \vec{p} = m \vec{v} $$
Questa definizione, però, non è invariante tra diversi sistemi inerziali, ossia sistemi che si muovono a velocità differenti tra loro.
La formula non funziona più quando le velocità si avvicinano alla velocità della luce ($ c $), perché il tempo e lo spazio non sono più assoluti.
Per mantenere la coerenza con la relatività di Lorentz, devo costruire una definizione che si trasformi correttamente in tutti i sistemi inerziali.
Nella relatività, la quantità di moto è una componente del quattro-vettore quantità di moto:
$$ P^\mu = m U^\mu $$
Dove $ m $ è la massa a riposo (invariante) di un corpo e $ U^\mu $ è il quattro-vettore velocità
$$ U^\mu = (\gamma c, \gamma \vec{v}) = (\gamma c,\gamma v_x, \gamma v_y, \gamma v_z) $$
Quindi:
$$ P^\mu = m U^\mu = m (\gamma c, \gamma \vec{v}) $$
$$ P^\mu = (\gamma m c, \gamma m \vec{v}) $$
$$ P^\mu = (\gamma m c, \gamma m v_x , \gamma m v_y , \gamma m v_z ) $$
La componente temporale $ P^0 = \gamma m c $ del quadrivettore corrisponde all’energia totale $ E= \gamma mc^2 $ divisa per $c $:
$$ P^0 = \frac{E}{c} = \frac{\gamma mc^2}{c} = \gamma mc $$
Le componenti spaziali $ P^i = \gamma m v_i $, invece, costituiscono la quantità di moto relativistica:
$$ \vec{p} = \gamma m \vec{v} $$
Questa quantità di moto è invariante in tutti i sistemi inerziali, pertanto rispetta la legge di conservazione della quantità di moto.
I due casi limite
Nel caso non relativistico la velocità $ v $ è molto più bassa della velocità della luce ossia $ v \ll c $.
In questo caso il fattore di Lorentz $ \gamma \approx 1$ tende a uno e la quantità di moto relativistica coincide con quella classica.
$$ \vec{p} \approx m\vec{v}) $$
Nel caso relativistico, invece, la velocità $ v $ si avvicina a quella della luce $v \to c $.
In questo caso il fattore di Lorentz $ \gamma \to \infty $ tende a infinito, quindi la quantità di moto cresce senza limiti, anche se la velocità non può mai raggiungere quella della luce $c$.
Relazione tra energia e quantità di moto
Il quattro-vettore quantità di moto controvariante è definito come
$$ P^\mu = (\gamma m c, \gamma m \vec{v}) = (\gamma m c, \gamma m v_x, \gamma m v_y, \gamma m v_z) $$
Per ottenere la forma covariante del vettore $ P_\mu = (\gamma m c, -\gamma m \vec{v}) $ utilizzo la metrica di Minkowski, quella con segno $(+,-,-,-)$.
$$ P_\mu = g_{\mu\nu} P^\nu $$
$$ P_\mu = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} P^\nu $$
$$ P_\mu = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} (\gamma m c, \gamma m v_x, \gamma m v_y, \gamma m v_z) $$
$$ P_\mu = (\gamma m c, -\gamma m v_x, -\gamma m v_y, -\gamma m v_z) $$
Il prodotto scalare tra le due versioni del quadrivettore è
$$ P^\mu P_\mu = ( \gamma mc \cdot \gamma mc ) + ( \gamma m v_x \cdot (- \gamma m v_x) ) + ( \gamma m v_y \cdot (- \gamma m v_y) ) + ( \gamma m v_z \cdot (- \gamma m v_z) ) ) $$
$$ P^\mu P_\mu = ( \gamma mc )^2 - ( \gamma m v_x )^2 - ( \gamma m v_y )^2 - ( \gamma m v_z )^2 $$
$$ P^\mu P_\mu = (\gamma m c)^2 - \gamma^2 m^2 (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) $$
$$ P^\mu P_\mu = (\gamma m c)^2 - \gamma^2 m^2 v^2 $$
$$ P^\mu P_\mu = \gamma^2 m^2 (c^2 - v^2) $$
Sapendo che il fattore di Lorentz è $ \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} $
$$ P^\mu P_\mu = m^2 \frac{c^2 - v^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}} $$
$$ P^\mu P_\mu = m^2 \frac{c^2 - v^2}{\frac{c^2-v^2}{c^2}} $$
$$ P^\mu P_\mu = m^2 ( c^2 - v^2 ) \frac{c^2}{c^2-v^2} $$
$$ P^\mu P_\mu = m^2 c^2 $$
Questo dimostra che il prodotto scalare è costante in qualsiasi sistema di riferimento.
Facendo un passo indietro
$$ P^\mu P_\mu = (\gamma m c)^2 - \gamma^2 m^2 v^2 $$
Sapendo che $ \gamma mc = \frac{E}{c} $
$$ P^\mu P_\mu = ( \frac{E}{c} )^2 - \gamma^2 m^2 v^2 $$
$$ P^\mu P_\mu = \frac{E^2}{c^2} - \gamma^2 m^2 v^2 $$
Quindi, il prodotto scalare è $ P^\mu P_\mu = m^2 c^2 $ e $ P^\mu P_\mu = \frac{E^2}{c^2} - \gamma^2 m^2 v^2 $
$$ P^\mu P_\mu = m^2 c^2 = ( \frac{E}{c} )^2 - \gamma^2 m^2 v^2 $$
ossia
$$ m^2 c^2 = \frac{E^2}{c^2} - \gamma^2 m^2 v^2 $$
Moltiplico per $ c^2 $ entrambi i membri
$$ c^2 ( m^2 c^2 ) = c^2 [ \frac{E^2}{c^2} - \gamma^2 m^2 v^2 ] $$
$$ m^2 c^4 = E^2 - \gamma^2 m^2 v^2 c^2 $$
$$ m^2 c^4 = E^2- ( \gamma m v )^2 c^2 $$
Sapendo che $ \vec{p} = \gamma m \vec{v} $ il cui modulo è $ | \vec{p} | = \gamma m v $
$$ m^2 c^4 = E^2 - p^2 c^2 $$
$$ E^2 = m^2 c^4 + p^2 c^2 $$
Questa è la relazione fondamentale dell’energia relativistica ed è una invariante di Lorentz.
Il termine $ m^2c^4 $ rappresenta l'energia a riposo $ E_0 = mc^2 $ mentre $p^2 c^2$ rappresenta il contributo dovuto al moto.
La somma dei due è l’energia totale di una particella relativistica.
I due casi limite
L’equazione generale $ E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4 $ descrive tutti i corpi, sia dotati di massa sia privi di massa.
Vediamo ora i due casi particolari più importanti.
- Corpo con massa a riposo
Se il corpo è fermo rispetto all’osservatore, la sua quantità di moto è nulla $ p = 0 $. Allora la relazione diventa: $$
E^2 = 0 + m^2 c^4 $$ $$ E^2 = m^2c^4 $$ $$ E = m c^2 $$ In questo caso, l’energia totale coincide con l’energia a riposo $E_0$, cioè l’energia che la massa possiede anche senza muoversi. È la famosa formula di Einstein. - Corpo senza massa (es. fotone)
Se la massa a riposo è nulla ($m = 0$), l’equazione diventa: $$ E^2 = p^2 c^2 + 0 \cdot c^4 $$ $$ E^2 = p^2 c^2 $$ $$ E = p c $$ Questo è il caso dei fotoni e di tutte le particelle prive di massa che non possono mai essere a riposo e si muovono sempre alla velocità della luce $c$. L’energia di un fotone dipende solo dalla sua quantità di moto (o, equivalentemente, dalla sua frequenza): $$ E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} $$Limiti significativi
Questi due casi mostrano come la relazione relativistica unifichi in un’unica espressione tutta la dinamica energetica della materia e della radiazione.
Per le particelle dotate di massa restituisce l’energia a riposo $E_0 = mc^2$, mentre per quelle prive di massa descrive l’energia puramente cinetica del moto alla velocità della luce.
In entrambi i casi, l’energia e la quantità di moto restano legate da una stessa legge invariante di Lorentz, che vale per ogni osservatore e in ogni sistema di riferimento.
Esempio numerico
Considero una particella di massa $ m = 1 \ kg $ che viaggia a una velocità $v = 0.6c$.
In questo caso il fattore di Lorentz è
$$ \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (0.6c)^2/c^2}} = 1.25 $$
La quantità di moto della particella è
$$ p = \gamma m v = 1.25 \times 1 \ kg \times 0.6c $$
$$ p = ( 0.75 \ kg ) \cdot c $$
Sapendo che la velocità della luce è $ c = 3\times10^8,\text{m/s} $ ossia 300mila km al secondo.
$$ p = 0.75 \ kg \times 3 \times 10^8 \ m/s $$
$$ p = 2.25 \times 10^8 \ kg·m/s $$
L'energia totale è
$$ E = \gamma m c^2 = 1.25 \times 1 \ kg \times (3\times10^8 \ m/s )^2 $$
$$ E = 1.25 \times 9\times10^{16} \ kg \ m^2/s^2 $$
$$ E = 1.125 \times10^{17} \ J $$
E così via.