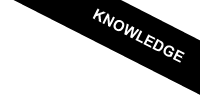I moti millenari della Terra
Oltre ai moti di rotazione e rivoluzione, la Terra esegue anche dei movimenti chiamati moti millenari che avvengono su scale temporali di migliaia di anni.
I moti millenari sono causati principalmente dall'attrazione gravitazionale esercitata da altri corpi del sistema solare, soprattutto dal Sole e dalla Luna.
Anche se non osservabili direttamente nel breve termine, questi movimenti influenzano la distribuzione e l'intensità dell'energia solare sulla superficie terrestre.
Quindi, contribuiscono ai cambiamenti climatici su scala millenaria. Ad esempio, modificano l'alternanza tra glaciazioni e periodi interglaciali.
Nota. Alcuni moti millenari sono oscillazioni irregolari, mentre altri seguono schemi ripetitivi e regolari, noti come cicli astronomici, poiché si verificano a intervalli definiti nel tempo. Esistono inoltre fenomeni 'ibridi', che presentano una certa regolarità ma possono essere alterati da fattori esterni imprevedibili, rendendoli meno precisi nel loro andamento.
La precessione luni-solare
La precessione luni-solare è il lento mutamento della direzione dell'asse terrestre determinato dalle forze gravitazionali combinate di Sole e Luna, che agiscono sul rigonfiamento equatoriale della Terra.
Poiché la Terra non è perfettamente sferica, ma presenta un rigonfiamento all'equatore, le forze gravitazionali tendono a spostare l'asse terrestre, provocando un movimento di precessione simile a quello di una trottola.
- Il lato del rigonfiamento più vicino al Sole o alla Luna è attratto con una forza maggiore rispetto al lato opposto. Questa attrazione tende a far spostare il piano dell'equatore verso il piano dell'orbita terrestre o lunare, generando così il fenomeno della precessione luni-solare.
- D'altra parte, la rapida rotazione terrestre produce una forza contraria che tende a conservare la direzione dell'asse terrestre.
La contrapposizione di queste due forze genera un moto doppio conico dell'asse terrestre, senza modificare l'inclinazione dell'asse, che compie un ciclo completo in circa 26.000 anni. E' chiamato così perché l'asse descrive un doppio cono.
Per capire questi movimenti, basta pensare alla precessione come a un movimento simile a quello di una trottola che cambia direzione lentamente nel tempo. Questo altera il punto in cui avviene il solstizio nel calendario e le stagioni.
Visto dal polo nord, il moto conico avviene in senso orario, ovvero in senso contrario al moto di rotazione terrestre.
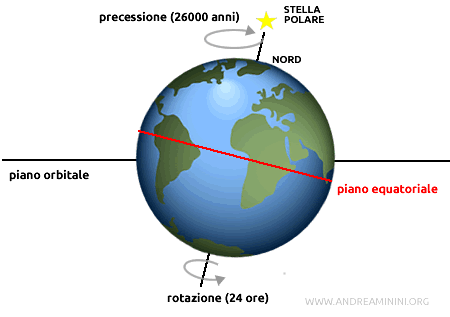
Di conseguenza, la direzione del piano equatoriale (perpendicolare all'asse) muta gradualmente nel corso del tempo rispetto al piano dell'orbita terrestre (eclittica) intorno al Sole.
Questo porta a un cambiamento graduale della posizione delle stelle rispetto alle stagioni e alla linea degli equinozi e dei solstizi.
Ad esempio, oggi la Stella polare indica il nord ma circa 11 mila anni fa era la stella Vega a farlo.
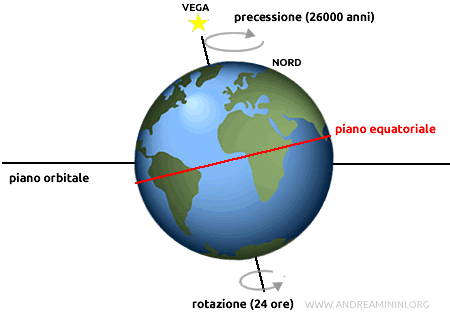
A causa di questo moto, gli equinozi si spostano all'indietro lungo l'eclittica, anticipando di circa 1 grado ogni 72 anni, circa 20 minuti ogni anno.
$$ \frac{365}{26.000} \cdot 24 \cdot 60 \approx 20.2 \ min $$
Tuttavia, il calendario gregoriano è progettato per correggere questi slittamenti, mantenendo l'equinozio di primavera vicino al 21 marzo.
Se il calendario non fosse aggiustato, l'equinozio di primavera si sposterebbe lentamente nel corso dei millenni, anticipando progressivamente.
Il termine "precessione" deriva dal latino praecedere, che significa "precedere". In astronomia, il nome si riferisce al fatto che il movimento dell'asse terrestre causa uno spostamento anticipato della posizione apparente delle stelle e dei punti di riferimento celesti nel te
In realtà la precessione luni-solare si riduce a 21.000 anni se considero anche un altro fenomeno.
A causa della forza gravitazionale del Sole e degli altri pianeti, l'asse maggiore del piano orbitale della Terra (l'asse tra l'afelio e il perielio) ruota in senso antiorario intorno al Sole con un periodo di 116.000 anni.
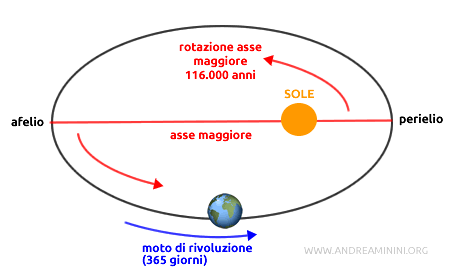
Quindi, complessivamente, un equinozio torna allo stesso momento dopo ventuno mila anni e non ventisei mila.
Le nutazioni
Il moto della precessione non è lineare, ma presenta oscillazioni ripetute nel corso di un ciclo di precessione, ciascuna delle quali è chiamata "nutazione".
Le nutazioni sono piccole oscillazioni dell'asse terrestre che si sovrappongono al movimento di precessione, originate dalle interazioni gravitazionali con la Luna e il Sole.
Variazioni dell'orbita terrestre
Oltre alla precessione, l'orbita terrestre subisce variazioni nell'eccentricità che oscilla tra una forma quasi circolare (eccentricità 0,005) e una forma più ellittica (eccentricità 0,06). In media ha un'eccentricità di 0,028.
In altre parole, l'orbita terrestre è più o meno schiacciata nel corso del tempo.
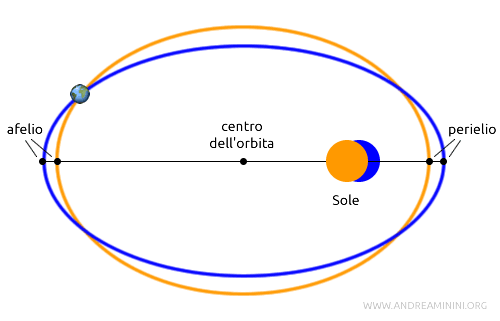
Nota. L'eccentricità di un'ellisse è definita come il rapporto tra la distanza dal centro dell'ellisse a uno dei suoi fuochi e il semiasse maggiore. Questo valore indica il grado di schiacciamento dell'ellisse, evidenzia quanto si discosta da una forma perfettamente circolare.
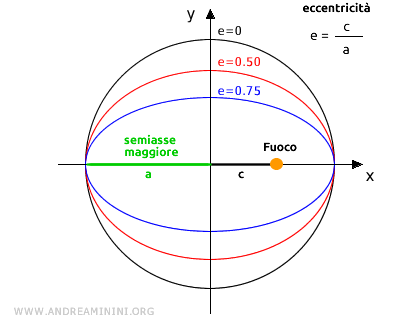
Questo ciclo ha una durata di circa 92.000 anni. Si stima che in questo periodo di tempo la distanza tra l’afelio e il perielio possa variare da circa 1 milione di chilometri fino a circa 16 milioni di chilometri. Attualmente, questa distanza è di circa 5 milioni di chilometri.
Le variazioni dell'orbita terrestre hanno un effetto importante sulla quantità di energia solare ricevuta dalla Terra in diversi momenti dell'anno, amplifica o attenua i cambiamenti climatici.
Inclinazione dell'asse terrestre
L'angolo di inclinazione dell'asse rispetto alla perpendicolare del piano dell'eclittica varia da 21°55' a 24°20' in circa 40.000 anni. Attualmente, è di 23°27'.
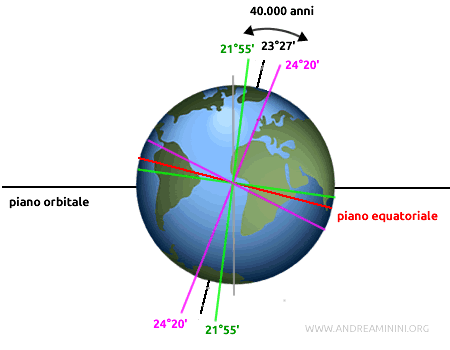
Anche questa variazione influenza direttamente la distribuzione dell'insolazione (energia solare ricevuta) nelle diverse latitudini.
Un'inclinazione maggiore dell'asse terrestre rispetto al piano dell'orbita aumenta il contrasto stagionale, rendendo le estati più calde e gli inverni più freddi, perché amplifica la quantità di luce solare ricevuta da ciascun emisfero durante le diverse stagioni.
- In estate, l'emisfero inclinato verso il Sole riceve i raggi solari più direttamente (angolo più perpendicolare), aumentando l'intensità della radiazione e quindi le temperature.
- In inverno, l'emisfero inclinato lontano dal Sole riceve i raggi solari con un'angolazione più obliqua, riducendo l'intensità della radiazione e abbassando ulteriormente le temperature.
Questo aumento delle differenze nell'illuminazione solare rende le estati più calde e gli inverni più freddi.
Effetti complessivi
Questi movimenti combinati, noti come cicli di Milankovitch, sono fondamentali per comprendere i cambiamenti climatici su scala millenaria, come l'alternanza tra periodi glaciali e interglaciali.
Ad esempio, una maggiore eccentricità dell'orbita amplifica le differenze stagionali. Un'asse più inclinato esalta il contrasto stagionale. La precessione determina quando avvengono i solstizi e gli equinozi lungo l'orbita.
Le fasi glaciali, della durata di circa 100 mila anni, sono caratterizzate da un raffreddamento generale del pianeta, che porta a un'espansione delle calotte glaciali, dei ghiacciai montani e delle aree ricoperte di neve.
Durante le glaciazioni grandi porzioni delle terre emerse alle alte latitudini vengono ricoperte da spessi strati di ghiaccio.
Al contrario, le fasi interglaciali sono molto più brevi, in genere della durata di poche migliaia di anni, e sono periodi di riscaldamento globale durante i quali le calotte polari si riducono, i ghiacciai si ritirano e il livello del mare si alza.
Nota. I segni di queste variazioni climatiche a lungo termine sono ampiamente documentati attraverso l'analisi di carote di ghiaccio, sedimenti marini, depositi glaciali e altre testimonianze geologiche.
Questa alternanza tra glaciazioni e periodi interglaciali non solo ha plasmato la geografia terrestre, lasciando tracce evidenti come morene glaciali, laghi glaciali e sedimenti, ma ha anche influenzato l'evoluzione degli ecosistemi e delle specie viventi, inclusa quella umana.
Ad esempio, l'adattamento dell'uomo a questi cambiamenti climatici ha contribuito al suo sviluppo tecnologico e sociale.
Durante le fasi glaciali, le comunità umane hanno dovuto affrontare condizioni estreme, come temperature rigide, scarsità di risorse alimentari e la necessità di migrazioni verso aree più favorevoli alla sopravvivenza.
Questi ostacoli hanno stimolato innovazioni tecnologiche, come la creazione di abiti e rifugi più adatti al freddo, l'uso del fuoco per riscaldarsi e cucinare, e strumenti più sofisticati per la caccia e la lavorazione dei materiali.

Allo stesso modo, i periodi interglaciali, caratterizzati da un clima più mite, hanno offerto opportunità per l'espansione demografica, lo sviluppo dell'agricoltura e la fondazione di insediamenti stabili.
Il passaggio da uno stile di vita nomade a uno sedentario ha permesso di sviluppare tecniche agricole, di conservazione del cibo e di allevamento, che hanno posto le basi per le prime società organizzate.
Nota. L'ultima era glaciale si è conclusa circa 10 mila anni fa, all'inizio dell'attuale fase interglaciale. È in questa fase intermedia che si sono sviluppate la preistoria e la storia dell'uomo.
Le conseguenze geologiche
Il moto di precessione e, in generale, i moti millenari della Terra, non hanno effetti diretti e immediati sulla geologia. Tuttavia, a lungo termine può influire sui processi terrestri in vari modi:
- Variazione del clima: I cicli di Milanković influenzano la distribuzione della radiazione solare, alterando i pattern climatici e contribuiscono all'alternarsi delle glaciazioni e dei periodi interglaciali. Questo può modificare il paesaggio geologico attraverso l'erosione, la sedimentazione e i processi glaciali.
Esempio. Durante le glaciazioni, l'avanzamento dei ghiacciai ha scolpito il paesaggio attraverso intensi processi di erosione e deposizione di sedimenti. Nei periodi interglaciali, il loro ritiro ha dato origine a morene e altre caratteristiche formazioni geologiche. Questi fenomeni hanno modellato la topografia, favorito la formazione di laghi glaciali e influenzato la distribuzione dei sedimenti, contribuendo alla diversità geologica che osserviamo oggi.
- Cambiamenti negli ecosistemi: Le variazioni climatiche associate alla precessione possono influenzare la vegetazione, i suoli e i sedimenti. In questo modo, indirettamente, incidono sul ciclo geologico.
- Sedimenti: Gli effetti della precessione si riflettono nei depositi sedimentari ciclici, visibili nei fondali marini e lacustri, dove si registrano variazioni climatiche legate ai cambiamenti orbitari o dell'inclinazione dell'asse terrestre.
Ad esempio, nei sedimenti marini e lacustri si possono osservare cicli stratigrafici che riflettono l'impatto delle variazioni dell'inclinazione dell'asse di rotazione tra 21,5° e 24,2°. Quando l'inclinazione aumenta, le stagioni diventano più estreme: estati più calde e inverni più freddi. Viceversa, quando diminuisce, le stagioni diventano più moderate, con un clima più uniforme.
In sintesi, questi moti millenari non solo definiscono il comportamento dinamico della Terra nello spazio, ma giocano anche un ruolo cruciale nel modellare il clima del nostro pianeta, l'ambiente e la storia dell'uomo.
E così via.