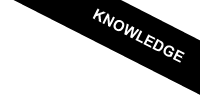Luna
In molti aspetti la Luna è uno specchio affascinante del nostro pianeta, con cui condivide una storia antica e comune. Entrambi si sono formati circa 4,5 miliardi di anni fa, presumibilmente da un gigantesco impatto tra la Terra primitiva e un corpo celeste delle dimensioni di Marte, chiamato Theia. Questa origine comune giustifica molte analogie nella composizione chimica e nella struttura.
Le missioni Apollo e le sonde robotiche hanno fornito dettagli cruciali sulla struttura interna della Luna, che presenta un nucleo, un mantello e una crosta, analogamente alla Terra, ma con proporzioni e composizioni differenti. La raccolta di campioni lunari ha svelato che la composizione isotopica delle rocce è sorprendentemente simile a quella terrestre, supportando l’ipotesi dell’origine comune.
Le caratteristiche della Luna
La Luna è un corpo quasi sferico, con un raggio di 1738 chilometri, equivalente a circa un quarto di quello terrestre, e una massa pari a 1/81 di quella della Terra. Non possedendo una fonte di luce propria, brilla riflettendo la luce del Sole. La sua gravità, molto inferiore rispetto a quella terrestre (circa 1/6), condiziona profondamente la sua capacità di trattenere gas e liquidi, il che spiega l'assenza di atmosfera e di mari superficiali.
In passato, anche la Luna era caratterizzata da un'attività vulcanica, durante la quale venivano rilasciati gas nell'ambiente. Tuttavia, a causa della scarsa gravità, questi gas si sono gradualmente dispersi nello spazio, lasciando il satellite privo di un'atmosfera stabile.
L'assenza di atmosfera
Priva di un’atmosfera, la Luna non gode di protezione dai micrometeoriti o di una regolazione termica, questo causa sbalzi estremi di temperatura tra il giorno e la notte e l'assenza di un crepuscolo. Durante il giorno lunare, le temperature raggiungono i 110 °C, mentre di notte precipitano a -150 °C. Inoltre, l’assenza di un filtro atmosferico rende il cielo lunare nero anche alla luce del giorno.
La mancanza di atmosfera e l’interazione costante con il vento solare hanno anche determinato la dispersione di eventuali riserve di acqua superficiale. Tuttavia, le esplorazioni spaziali hanno rivelato la possibile presenza di ghiaccio nei crateri polari, protetto dall’ombra perenne e intrappolato sotto detriti isolanti.
Il paesaggio lunare
La superficie lunare è un mosaico di mari e terre alte. I mari ci appaiono come macchie scure sulla superficie lunari ma sono grandi pianure formate dall'impatto con meteoriti, successivamente colmate da lava vulcanica che hanno reso quasi liscio il fondo del cratere.
Queste regioni scure contrastano nettamente con le terre alte che dominano il 70% della faccia visibile e quasi tutta quella nascosta. Le terre alte sono molto più luminose, sono caratterizzate da crateri e rilievi che raggiungono altezze superiori ai 5000 metri (es. Mons Huygens) e dislivelli di oltre 8000-9000 metri.
Va detto che sulla Luna non c'è il "livello del mare" come sulla Terra... quindi non c'è un riferimento unico per la misura dell'altezza.
La maggior parte dei crateri lunari è di origine da impatto, con dimensioni che variano notevolmente, da pochi metri fino a molti chilometri di diametro. Esistono anche crateri formati dall'antica attività vulcanica del satellite, generalmente di piccole dimensioni e oggi completamente inattivi.
Il suolo lunare è ricoperto da uno strato di frammenti rocciosi e polvere, detto regolite, generato dall’incessante bombardamento meteorico. Questo manto è una cronaca fossile degli eventi che hanno modellato il satellite, preservando intatte le tracce di impatti risalenti a miliardi di anni fa, dato che l'assenza di atmosfera impedisce l'erosione.
La Luna è anche una finestra sul passato del sistema solare perché il suo paesaggio è quasi immutabile. In quanto privo di erosione e di atmosfera, la superficie lunare conserva intatte le tracce degli impatti che hanno interessato il sistema solare nei primi miliardi di anni.
L'origine della Luna
L'origine della Luna è stata oggetto di numerose teorie nel corso degli anni, ciascuna basata su evidenze scientifiche e osservazioni. Tra le principali ipotesi formulate ci sono:
- Ipotesi dell'impatto gigante
Secondo questa teoria, la Luna si sarebbe formata in seguito a una colossale collisione tra la Terra primordiale e uno o più planetesimali, probabilmente un corpo delle dimensioni di Marte noto come Theia. I materiali espulsi dall'impatto sarebbero rimasti in orbita attorno alla Terra, aggregandosi progressivamente fino a formare il nostro satellite naturale. Questa è attualmente l'ipotesi più accreditata. - Ipotesi dell'accrescimento
La Luna si sarebbe originata dall’aggregazione di materiali presenti nell’orbita terrestre durante le fasi iniziali della formazione del pianeta. Sebbene plausibile, questa teoria non spiega completamente alcune caratteristiche chimiche della Luna, come le sue discrepanze rispetto alla Terra. - Ipotesi della fissione
Secondo questa ipotesi, la Luna si sarebbe distaccata dalla Terra primordiale, ancora in uno stato fuso e soggetta a una rapida rotazione. Alcuni scienziati hanno ipotizzato che questa separazione abbia formato il bacino dell’Oceano Pacifico. Tuttavia, mancano evidenze solide per supportare questa teoria, che rimane meno considerata rispetto alle altre. - Ipotesi della cattura
Questa teoria propone che la Luna sia un corpo indipendente, formato altrove nel sistema solare e successivamente catturato dal campo gravitazionale terrestre. Sebbene interessante, questa spiegazione presenta difficoltà nel giustificare le somiglianze compositive tra Luna e Terra.
Attualmente l'ipotesi dell'impatto gigante risulta essere la più accreditata, perché è supportata da prove chimiche e isotopiche che effettivamente mostrano una composizione simile tra le rocce lunari e terrestri.
I moti della Luna
La Luna compie diversi movimenti in modo simultaneo, ciascuno dei quali contribuisce alla sua dinamica e alle sue interazioni con la Terra e il Sole. Questi movimenti includono la rotazione, la rivoluzione e la traslazione, ciascuno è caratterizzato da particolari proprietà e implicazioni.
- Moto di rotazione. La Luna ruota intorno al proprio asse in senso antiorario (da Ovest a Est), completando un giro in 27 giorni, 7 ore, 43 minuti e 12 secondi (mese sidereo).
- Moto di rivoluzione. La Luna orbita attorno alla Terra in senso antiorario, su un’orbita ellittica. La distanza varia tra:
- Perigeo: 356.000 km (punto più vicino).
- Apogeo: 407.000 km (punto più lontano).
- Distanza media: 384.000 km.
Oltre a questi moti la Luna ha anche un moto di traslazione, perché si muove attorno al Sole insieme alla Terra con la stessa velocità angolare.
Il periodo di tempo necessario per ripetere lo stesso allineamento Terra-Luna-Sole è di 29 giorni, 12 ore, 44 minuti e 3 secondi, detto mese sinodico.
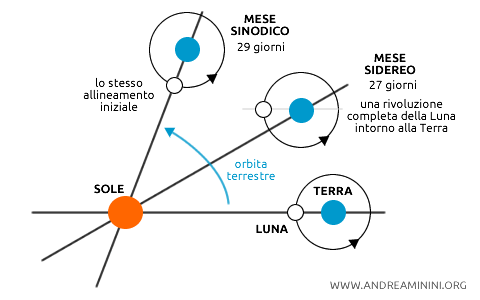
Il mese sinodico è superiore al mese sidereo, poiché la Terra si sposta lungo la sua orbita solare. È la base dei calendari ed è arrotondato a 30 giorni.
La linea dei nodi
Il piano dell’orbita lunare forma un angolo di 5°09' rispetto al piano dell’orbita terrestre, chiamato piano dell’eclittica.
Quindi, i due piani non coincidono, ma si intersecano lungo una linea immaginaria detta linea dei nodi.
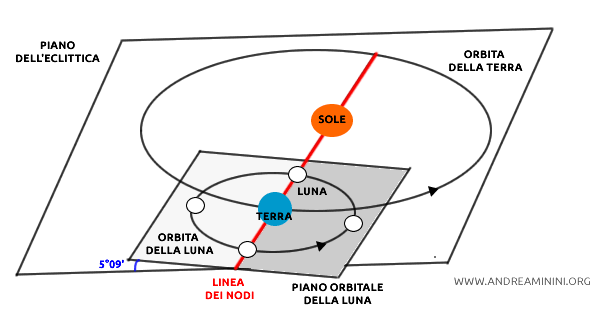
Questa linea rappresenta i punti in cui la Luna attraversa il piano dell’eclittica, dirigendosi alternativamente "sopra" e "sotto" di esso.
Gli allineamenti Sole-Terra-Luna possono avvenire soltanto quando la Luna si trova esattamente su questa linea dei nodi.
È in queste condizioni che si verificano fenomeni spettacolari come le eclissi solari e lunari:
- Eclissi solari
Si verifcano quando la Luna si frappone tra la Terra e il Sole. - Eclissi lunari
Si verificano quando la Terra si trova tra il Sole e la Luna, proiettando la sua ombra sul satellite
Tuttavia, l’inclinazione di 5°09' rende questi eventi relativamente rari, poiché l’allineamento perfetto può avvenire solo in determinati periodi durante l’anno, quando la linea dei nodi è orientata in direzione del Sole.
E così via.